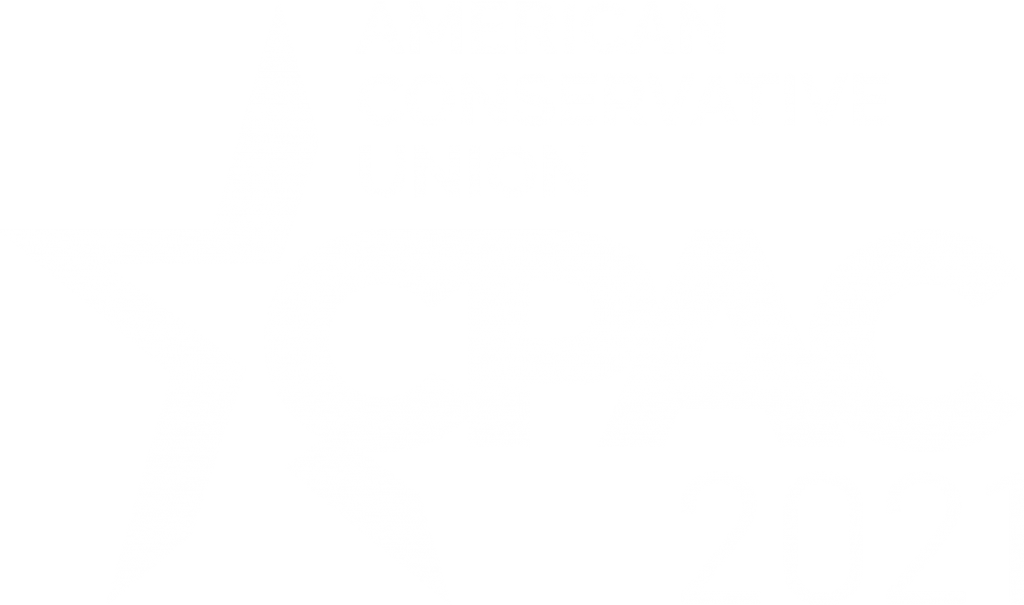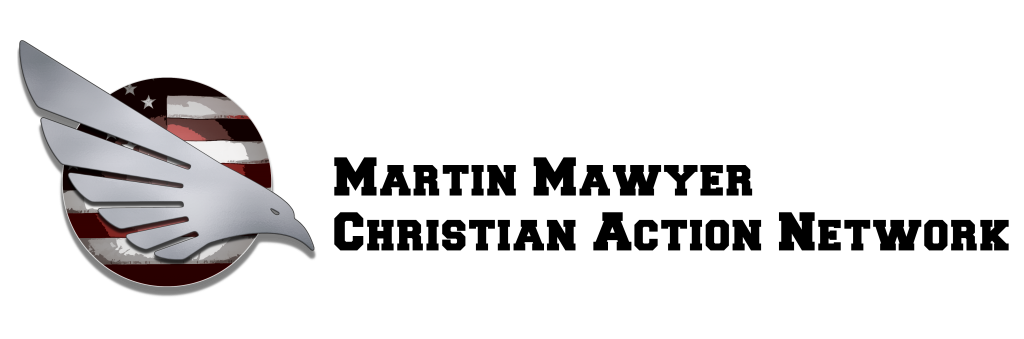Quei due uomini che cadono dal carrello dell’aereo in decollo da Kabul precipitano in un cerchio tragico della storia, senza rete, largo vent’anni. A chiunque ne hanno ricordati altri che, l’11 settembre 2001, si lanciavano per non bruciare dentro le torri gemelle. Tutti quanti, ora e allora, fuggivano da una morte lenta: non sceglievano un’impossibile salvezza, ma solo una fine più rapida.
Vent’anni fa gli aerei portatori di morte colpivano New York. Erano partiti da altre città dell’America, ma in realtà da molto più lontano, dalle basi di Al Qaeda in Afghanistan, dove quegli atti di terrore erano stati congegnati. Adesso altri aerei tentano una rotta simile, dalla capitale afghana verso l’Occidente, ma per fornire riparo ai pochi riusciti a salire a bordo. L’intento è diverso, l’esito in parte lo stesso: piccole esistenze vengono scaricate. Le respinge il cielo, pretesa senza fondamento. Le attrae la terra, il suo campo di gravità è un destino letale. Diciamo di quei corpi che sono in “caduta libera” e mai espressione fu più mistificante. Si lasciano andare perché sono già prigionieri di un futuro inaccettabile al cui disegno non hanno contribuito. Lo fanno per una forma di disperazione paradossalmente minore. I sopravvissuti alla ritirata di Russia raccontano che “era più facile lasciarsi morire”: metteva fine alla fatica e al dolore. Superavano cadaveri con volti pacificati, proseguendo verso una vita che non li avrebbe mai portati lontano da lì, nella depressione dei giorni e nel tormento delle notti. La disperazione maggiore è loro, di tutti quelli che si consegnano alla storia come promessa, se non come risarcimento, che diventano profughi, orfani, vedove per poter essere testimoni e dire che “non si ripeterà”.
Invece accade ancora. Vent’anni non sono niente, è un frusciar di pagine, ma all’indietro. Rivediamo video analoghi, preceduti da scritte che inducono alla cautela perché non “venga urtata la nostra sensibilità”. Povere stelle. Anche per questo non ci è stato detto molto di quel che stava accadendo. A un certo punto abbiamo saputo che “i nostri” se ne stavano andando. Poi che “i cattivi” stavano tornando, sarebbero arrivati fra tre mesi, forse uno: erano già lì. Viviamo tragedie epocali ma non riusciamo mai a immaginare il peggio: che le torri crolleranno, che Kabul non resisterà.
Abbiamo costruito una cultura di carta velina per separarci dalla sofferenza e dalla morte. La squarciano visioni che definiamo impensabili. Quei puntini che scendono, chi sono? Restano nell’ignoto. Poiché si schiantano ci fanno la grazia di rendersi irriconoscibili: non diamo loro un nome, una vicenda, un lavoro dalle 9 alle 5, un matrimonio recente, una passione costante. Eppure precipitano in un vuoto che dovremmo conoscere perché abbiamo contribuito a crearlo in vent’anni sprecati, andata e ritorno per non rimediare a niente, non creare nulla. Inermi, ci ripariamo dietro l’arte, evochiamo Golconda di Magritte o il Falling Man di DeLillo, di cui vale riscrivere questa frase: “Nessuno sapeva ciò che sapevano loro nell’ultimo minuto di chiarezza, prima della fine di tutto”. Il sospetto è che dall’alto vedessero la storia rincorrersi in cerchio intorno a una voragine.