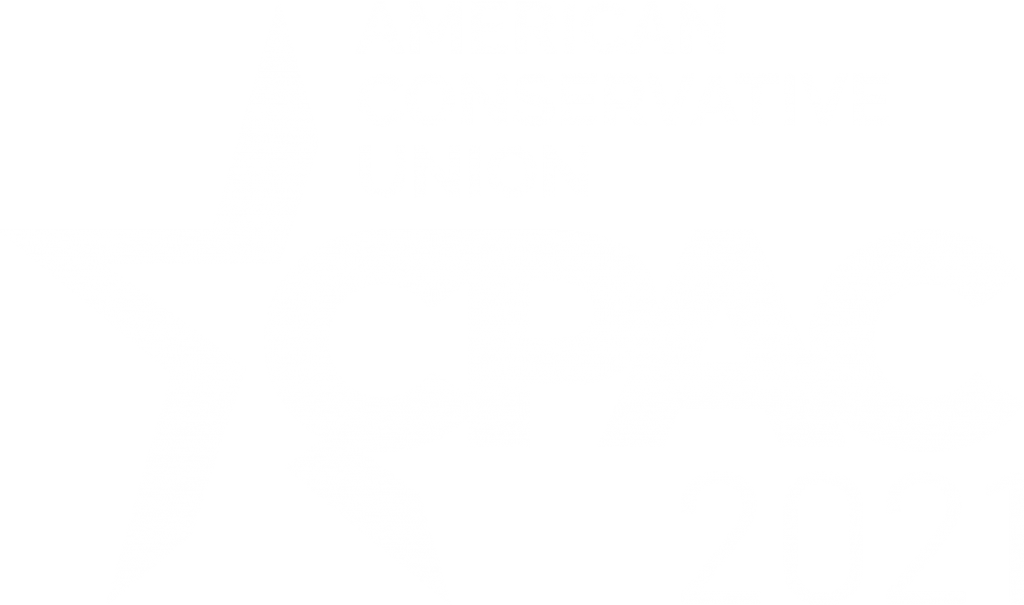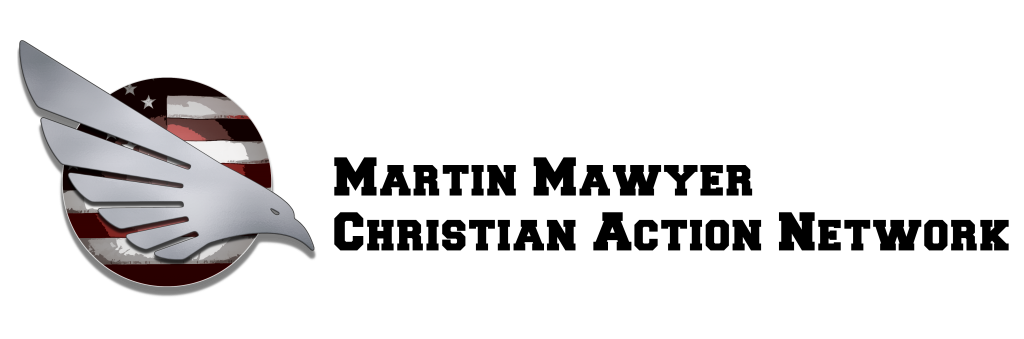Avevo quattro anni quando Saigon cadde, quindi non ricordo niente di quanto successe. Mi considero fortunato, tenuto conto che molti vietnamiti sopravvissuti alla fine di quella guerra ne rimasero traumatizzati in modo grave e indelebile. La caduta del regime sudvietnamita appoggiato dall’America iniziò dalla mia città natale, Ban Me Thuot, negli Altopiani centrali del Vietnam, nel marzo 1975. In meno di due mesi tutto il Vietnam del Sud capitolò e si arrese ai nordvietnamiti. I militari fuggirono in una ritirata caotica insieme ai civili. Mia madre, mio fratello e io ci trovammo in mezzo a loro. Lasciammo a casa una sorella adottata. Dopo aver percorso a piedi quasi 200 chilometri per eludere l’esercito nordvietnamita in piena avanzata, raggiungemmo la città di Nha Trang, sulla costa, dove riuscimmo a trovare una imbarcazione che ci condusse a Saigon, dove si trovava mio padre.
Fummo fortunati. Molti altri non lo furono. Mio fratello ricorda che dagli alberi penzolavano i paracadutisti sudvietnamiti morti. A Nha Trang, alcuni civili in fuga persero la vita cadendo in acqua, nel tentativo di montare sui barconi. A Da Nang, i soldati disperati si accalcarono riempiendo l’intera stiva di un aereo, mentre chi era rimasto a terra lanciava granate e apriva il fuoco contro la fusoliera. Adesso, le immagini di corpi in caduta libera in cielo, di persone che fuggono in preda alla disperazione, ritornano a noi dalla capitale afghana Kabul. I paragoni con il Vietnam sono comparsi presto nello sventurato intervento americano in Afghanistan: si trattava della classica missione strisciante, di un ginepraio, di un’altra guerra infinita. Il pessimismo era garantito. Vent’anni dopo, miliardi di dollari e decine di migliaia di morti più tardi, le milizie talebane oggi sono a Kabul, dopo essersi assicurate il controllo del Paese intero a una velocità vertiginosa. Quantunque alcuni esponenti politici americani lo neghino, l’analogia dunque si ripresenta, e la caduta di Saigon con il disastro che ne derivò lascia presagire il possibile destino di decine di migliaia di afghani. All’amministrazione Biden, però, tutto ciò non interessa. «Questa non è Saigon», ha detto il segretario di Stato Antony Blinken il finesettimana scorso.
È vero: i talebani non sono l’Esercito popolare vietnamita e l’evacuazione americana da Saigon, benché caotica, fu programmata molto meglio della mossa finale americana in Afghanistan. L’analogia con Saigon, tuttavia, è importante perché l’emergenza e la catastrofe umanitaria sono simili ed è importante anche per il ruolo che gli Stati Uniti e le altre nazioni dovranno avere per influire sul destino degli afghani. Di conseguenza, lunedì è stato scoraggiante ascoltare il presidente Biden difendere la sua politica concentrandosi su due alternative – restare e combattere o ritirarsi – addossando al contempo la maggior parte della responsabilità dell’attuale situazione al governo e all’esercito afghani. L’accusa agli afghani offusca una storia di errori di valutazione commessi dall’America e iniziata con il presidente George W. Bush, e consente a Biden di trattare l’evacuazione degli alleati afghani come un ripensamento, più che una priorità. Per questi civili, la guerra non è finita e non finirà per molti anni a venire. Il loro futuro – e il ruolo che Biden avrà nel determinare se sarà un futuro di riassestamento e un nuovo inizio, oppure un futuro di terrore e miseria – consentirà di capire se l’America potrà continuare ad affermare di sostenere sempre i suoi alleati.
Da studioso del passato e da scrittore che si è occupato della guerra del Vietnam ho riflettuto spesso sul 1975 e sulle sue conseguenze. Sono cresciuto in una comunità di rifugiati vietnamiti così profondamente condizionata dalla caduta di Saigon che ancora oggi il mese di aprile è chiamato ‘Black April’ ed è commemorato tutti gli anni. Per questo motivo, quando ho letto l’articolo scritto da un’anonima giornalista afghana da uno dei territori conquistati di recente dai talebani, mi sono tornate subito in mente le parole e le testimonianze ascoltate dai rifugiati vietnamiti: «La mia vita è stata obliterata in pochi giorni. Sono molto spaventata e non so che ne sarà di me. Ritornerò mai a casa? Rivedrò i miei genitori? Dove andrò? L’autostrada è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Come farò a sopravvivere?». Le domande della giornalista sono angoscianti più che mai, ora che le emittenti trasmettono di continuo immagini di suoi connazionali che, nel tentativo di scappare e aver salva la vita, si accalcano all’aeroporto di Kabul. Le sue domande quasi sicuramente sono simili a quelle che si posero i miei genitori e molti altri rifugiati vietnamiti.
Ancora una volta, noi fummo fortunati. La mia famiglia cercò di scappare in aereo, ma non riuscì a raggiungere l’aeroporto di Saigon. Ci dirigemmo allora verso l’Ambasciata degli Stati Uniti, senza riuscire a fendere la ressa di persone. Alla fine, al porto trovammo una chiatta in partenza, lasciammo Saigon e arrivammo negli Stati Uniti, dove iniziammo una nuova vita. Eravamo civili, ma la nostra è una storia di guerra.
Agli americani piace immaginare storie di guerra che hanno per protagonisti i loro eroici soldati, marinai e piloti. In realtà, le storie dei rifugiati sono anch’esse storie di guerra. Malgrado nel Paese stia crescendo un profondo sentimento antibellico, per gli Stati Uniti è difficile perdere le abitudini belliche acquisite, in parte perché siamo un apparato militare-industriale progettato per la guerra, e in parte perché perfino i racconti contro la guerra nei quali compaiono soldati sono pur sempre incentrati sul fascino seducente dell’artiglieria, delle armi, dell’eroismo e della forza virile.
Nelle storie dei civili assassinati o mutilati o costretti a fuggire o resi orfani dalla guerra non ci sono né potere né gloria. Le vere storie di guerra sono quelle vissute dai civili, simili a quelle che in questo stesso momento stanno vivendo molti afghani. Continuiamo a sentirci dire che gli americani soffrono di affaticamento bellico, ma quante storie di soldati americani in guerra leggiamo o ascoltiamo o vediamo rispetto a quelle di rifugiati diventati tali a causa delle guerre guidate dagli Stati Uniti? Le storie civili di guerra traviano la nostra forma mentis, per la quale essere a capo di una guerra perenne è un indiscusso privilegio americano. Agli americani piace pensare anche che le guerre finiscono quando loro dichiarano che sono finite. In Vietnam, i vietnamiti vittoriosi catturarono un numero incalcolabile di soldati sudvietnamiti, di politici, di religiosi, di prostitute e di altre persone ancora e li segregarono nei campi di rieducazione, dove in molti morirono di malattie, stenti e lavori forzati. Altri ancora furono giustiziati. Le condanne andarono da qualche mese a più di dieci anni di reclusione.
Molti di quei prigionieri verosimilmente provarono le stesse sensazioni della giornalista afghana che descrive il suo smarrimento per essere diventata una rifugiata alla mercé dei talebani: «Ricordo urla e pianti. Le donne e i bambini intorno a me scappavano in ogni direzione. Sembrava che fossimo tutti prigionieri a bordo di una stessa barca e che intorno a noi infuriasse una tempesta enorme». La giornalista parla per metafore, ma nei decenni successivi alla caduta di Saigon quasi un milione di vietnamiti scappò per mare. Decine di migliaia di vietnamiti persero la vita in tentativi di fuga disperati. I più fortunati raggiunsero i campi per rifugiati e da lì approdarono poi nei Paesi che li accolsero. I meno fortunati rimasero a marcire in quei campi per anni, addirittura decenni. Fanno parte a tutti gli effetti del bilancio di vite umane perse che ha continuato a crescere per anni dopo la fine ufficiale della guerra. Questo è quanto si prospetta adesso per il popolo afghano, con la certezza che non appena i talebani si impadroniranno di Kabul si vendicheranno in modo tremendo degli afghani che si erano alleati con gli americani.
Vedendo arrivare il fine settimana scorso richieste di aiuto sempre più disperate dagli afghani, era auspicabile che il paragone con la caduta di Saigon inducesse l’amministrazione Biden a fare il suo dovere con maggiore tempestività e ad aiutare i suoi alleati afghani a fuggire dal Paese. Invece, per gli americani l’analogia con Saigon comporta il rischio di considerare la tragedia in corso in Afghanistan semplicemente come molti considerarono la fine del regime sudvietnamita: una spettacolarizzazione, un episodio come un altro della Storia.
In verità, la caduta di Saigon dette inizio a molti anni di terrore e disperazione per gli sconfitti. Nel caso dell’Afghanistan, Biden ha promesso di evacuare in luogo sicuro un numero non meglio precisato di afghani in pericolo. Forse, in reazione al comune sentire a livello interno, contrario all’immigrazione, gli Stati Uniti stanno cercando di trovare riparo per molti rifugiati afghani in altri Paesi. Ma non basta. «Il popolo afghano non merita tutto questo», ha dichiarato su Twitter lo scrittore Khaled Hosseini. «Gli Stati Uniti hanno un obbligo morale preciso. Che accolgano quanti più rifugiati possibile».
La Storia si ripete, e si ripete sotto forma di tragedia e di farsa. Le guerre in Vietnam e in Afghanistan sono il risultato dell’arroganza americana e in entrambi i casi gli americani hanno prestato attenzione perlopiù ai loro costi politici di guerra. In entrambi i casi, invece, sono i vietnamiti (e i laotiani, i cambogiani, i hmong) e gli afghani ad aver pagato lo scotto più alto in termini di sofferenza umana. Nell’aprile del 1975, gli Stati Uniti riconobbero la loro responsabilità morale ed evacuarono circa 130 mila vietnamiti, accogliendo nei decenni a seguire centinaia di migliaia di altri civili provenienti da Vietnam, Laos e Cambogia. Questo è quanto si deve ripetere oggi: qualsiasi altra soluzione non all’altezza di questo scenario di senso di responsabilità e di accoglienza aggraverà il fallimento americano.
Nel 1975 Joe Biden era senatore e di sicuro ricorda che la maggioranza degli americani non desiderava accogliere rifugiati provenienti dal sudest asiatico. Ciò nonostante, il Congresso fece la cosa giusta e la successiva prosperità delle varie comunità di americani del sudest asiatico negli Stati Uniti ha avvalorato la saggezza di quella decisione morale. Se la politica all’origine di queste due guerre americane fallimentari è differente, il senso etico è uno solo. Decine di migliaia di afghani hanno creduto alle promesse americane: avrebbero ricevuto libertà, democrazia e una società aperta e tollerante. Adesso, invece, sono in trappola. Per gli afghani la guerra non è finita soltanto perché noi, gli Stati Uniti, abbiamo dichiarato che è finita.
Per gli afghani l’incubo non finirà dopo che l’ultimo americano se ne sarà andato. Il nostro obbligo morale di aiutare gli afghani che corrono il rischio di perdere la vita va aldilà del presente e si spinge molto oltre negli anni a venire. Gli Stati Uniti devono assumere il comando delle operazioni di evacuazione e accogliere decine di migliaia dei loro alleati afghani. In caso contrario, si riveleranno tristemente veritiere le parole di un’altra giovane donna afghana che riflette sul futuro del suo Paese: «Noi non contiamo perché siamo nati in Afghanistan… A nessuno importa di noi. Spariremo lentamente dalla Storia».
Viet Thanh Nguyen, 50 anni, americano di origine vitenamita, ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa con il romanzo “Il simpatizzante”, seguito da “Il militante”. È docente di inglese, americanistica e letteratura comparata presso l’University of Southern California.
Traduzione di Anna Bissanti
© 2021, The New York Times