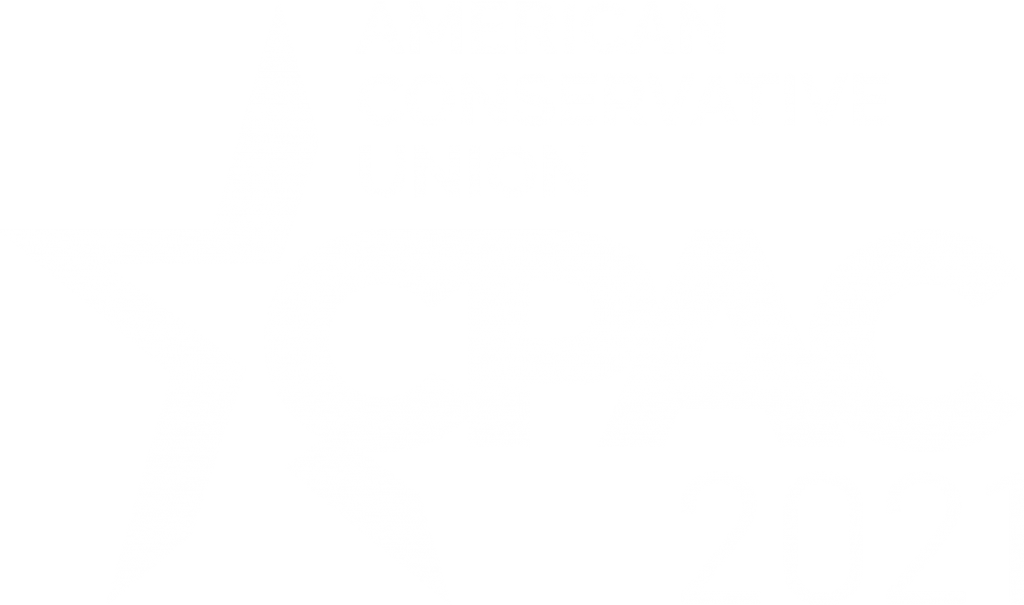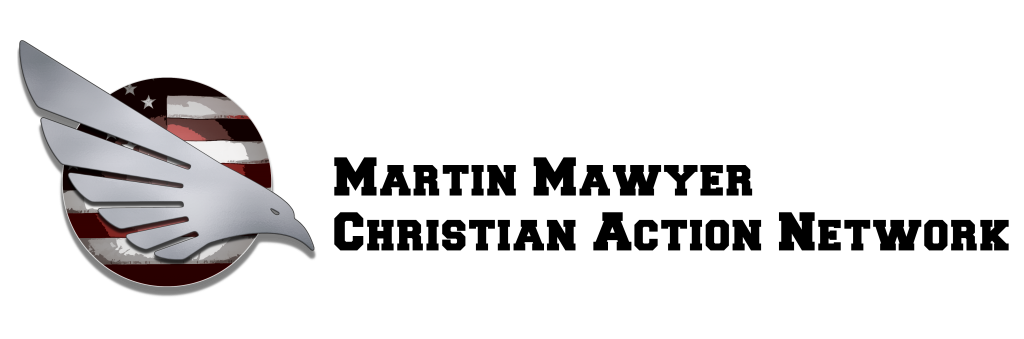“Se rimani sei settimane in un paese scriverai un libro con animo leggero. Se rimani sei mesi, farai fatica a scrivere un articolo. Se rimani sei anni, non scriverai più”. Il suggerimento arriva da una grande esperta di montagne afgane, la scrittrice e fotografa svizzera Annemarie Schwarzenbach, che ha affrontato più volte quella sorta di viaggio sulla Luna che dal nord del paese, dai confini del Tagikistan, porta giù fino alla capitale Kabul, attraverso la mitica valle del Panshir.
Con un mujaheddin armato di bazooka a Taloqan
Dodici settimane è durata la mia prima esperienza in Afghanistan, da ottobre a gennaio del 2002. Poche settimane dopo l’attacco alle Torri Gemelle, organizzato dalla rete di Osama Bin Laden con la protezione del regime talebano. Un periodo comunque breve per capire a fondo un paese, travolto già nel 2001 da 23 anni di guerra che ne hanno deformato l’identità, la storia e persino la geografia. Una guerra d’altri tempi, con condizioni, mezzi e armamenti che ricordano più la prima della seconda guerra mondiale.
Un lunga guerra di posizione, tra trincee contrapposte, osservando da vicino la lenta avanzata dei mujaheddin dell’Alleanza del Nord, guidati fino a poco prima dal leggendario leone del Panshir, il comandante Ahmad Shah Massud. Fino alla sconfitta talebana, con la disordinata fuga da Kabul. Di certo uno degli ultimi conflitti che i giornalisti hanno potuto osservare, sentire, quasi toccare da vicino. Tanto vicino che alcuni di loro ci hanno rimesso la pelle.
Sul carrarmato con i bambini a Koja Bahauddin, Nord Afghanistan
Per me allora, giovane inviato del Tg5, una esperienza unica, con la possibilità di raccontare un viaggio indietro nel tempo, tra trincee fangose, sentieri minati, torrenti da guadare a cavallo e vecchi padelloni satellitari al posto dei telefonini portatili. Dai tramonti sulle pendici dell’Hindu Kush alle albe nella vallata Bamiyan (già orfana dei colossali Buddha) con, sullo sfondo, i paesaggi mozzafiato di fortezze medievali che rimandano a quelle immaginarie narrate da Buzzati nel “Deserto dei tartari”.
Dell’Afghanistan letterario e misterioso, ricco di verde e di acqua, quello raccontato dalla stessa Schwarzenbach come “la Svizzera dell’Asia”, non c’è più traccia. L’arrivo nell’accampamento di Khoja Bahauddin, a pochi chilometri dal confine con il Tagikistan, il luogo dove Massud venne assassinato da due kamikaze arabi travestiti da cameraman, è un bel pugno in pancia. Niente di leggendario, condizioni estreme: le poche case sono di fango, le più lussuose con le plastiche al posto delle finestre.
Il senso di alienazione è forte. Le trincee sono popolate di mujaheddin accasciati vicino ai loro escrementi. L’energia elettrica arriva solo dai pochi gruppi elettrogeni, l’acqua potabile è il bene più ambito. In breve i giornalisti stranieri, noi compresi, si trasformano in una sorta di zombie, coperti perennemente di polvere e fango dalla testa ai piedi. Ad osservarli una sgangherata truppa di guerrieri dai turbanti sgargianti che affila le baionette dei kalashnikov costruiti artigianalmente in Pakistan con scarti di ferro vecchio.
Sulla strada per Kabul
Ai loro occhi i giornalisti rivestiti di goretex, con le sahariane di ordinanza, sembrano un pò ridicoli. A pochi metri ci sono le trincee del fronte di Dashte-Qalà, tre lunghe gallerie profonde non più di un metro e mezzo, scavate lungo un crinale di un paio di chilometri. Sulle alture davanti le postazioni talebane sono a malapena visibili. Tutto sembra fermo, immobile, fino a quando, a intervalli regolari, si sente un colpo di mortaio, una raffica di mitra oppure un colpo di cannone. Nessuno, tra i soldati ci fa troppo caso. Solo quando di tanto in tanto un razzo sfiora le nostre postazioni la trincea si anima per qualche minuto. Oppure quando i bombardieri B52 sganciano il loro carico sulle teste dei guerrieri talebani.
I primi giorni trascorrono nell’attesa tra piccole avventure: solo per arrivare al fronte bisogna attraversare il fiume Khoja, ingrossato dalle piogge, su instabili zatteroni appoggiati su camere d’aria rubate a qualche camion di passaggio, oppure in groppa a qualche mulo già stracarico di armi e munizioni.
La mattina dell’11 novembre 2001 a ridosso del fronte si coglie una strana eccitazione. Dopo tanta attesa il segnale dell’attacco finale alle linee talebane sembra prossimo. Il sole, ancora basso penetra nei cunicoli e i soldati cercano gli spiragli di luce per riscaldarsi le ossa. I comandanti dei mujaheddin non captano più nulla via radio dalle linee nemiche. Silenzio, sembra che i talebani abbiamo deciso di ritirarsi senza sparare un colpo. E così propongono agli inviati dei media stranieri di perlustrare, a bordo di piccoli cingolati, le trincee appena abbandonate dai talebani.
Batteria di mortaio sulla strada a Taloqan
Con i miei compagni di viaggio, un fotoreporter milanese, un inviato delle tv libanese Mbc, decidiamo a malincuore di lasciar perdere, di non sfruttare l’occasione. Non abbiamo con noi i giubbotti antiproiettile e poi non riusciremmo comunque a spedire il servizio in tempo per i notiziari della sera. Tanto ci saranno altre occasioni. Con un po’ di invidia vediamo salire gli altri colleghi su improbabili cingolati di fabbricazione sovietica. Due di loro li conosciamo bene: con Johanne Sutton, 34enne inviata di Radio France International, una lunga esperienza alle spalle in Medio Oriente, e Pierre Billaud, collega radiofonico di Rtl, abbiamo condiviso nei giorni precedenti caffè e sigarette, sdraiati sui tappeti dell’accampamento di Khoja Bahauddin. Con loro c’è anche un inviato del settimanale tedesco Stern, Volker Handloik, 38 anni, free lance. Prima di partire per il sopralluogo delle trincee Volker mi confida di aver bisogno di una pausa. E’ nel nord dell’Afghanistan già da qualche tempo ed ha bisogno di staccare per scaricare lo stress accumulato negli ultimi giorni: “Domani – confida – me ne torno in Tagikistan e prendo il primo aereo per Monaco”.
Toccherà al sottoscritto, 24 ore dopo, andare a raccogliere i loro poveri corpi trafitti prima dai colpi di mitra dei talebani e poi straziati dai cingolati degli stessi tank costretti, dopo la sorpresa dell’ imboscata, a fare velocemente marcia indietro. Le informazioni arrivate agli ufficiali dell’Alleanza del Nord si sono rivelate errate: i talebani non erano fuggiti. Così i mezzi dei mujaheddin, e i giornalisti con loro, sono finiti ben presto sotto il tiro incrociato delle batterie nemiche.
In un contesto del genere diventa molto facile perdere il contatto con la realtà, quella davanti ai tuoi occhi, in bilico perenne tra Medioevo e Grande Guerra, e quella a migliaia di chilometri di distanza in redazioni dove, attraverso il telefono satellitare, arrivano le richieste più assurde. L’imprudenza di seguire i carri armati di notte per vedere le trincee nemiche, oppure l’eccessiva fiducia nelle parole dei mujaheddin, di certo la grande passione per il proprio lavoro è costata la vita a questi colleghi poco più che trentenni. Poche ore dopo le milizie dell’Alleanza del Nord faranno la loro entrata trionfale a Kabul dove i talebani sembrano essersi volatilizzati.
E’ passato un giorno o poco più dalla tragica fine di Johanne, Pierre e Volker e i loro nomi, la loro morte sarà già una notizia vecchia, carta straccia nei cestini delle redazioni.