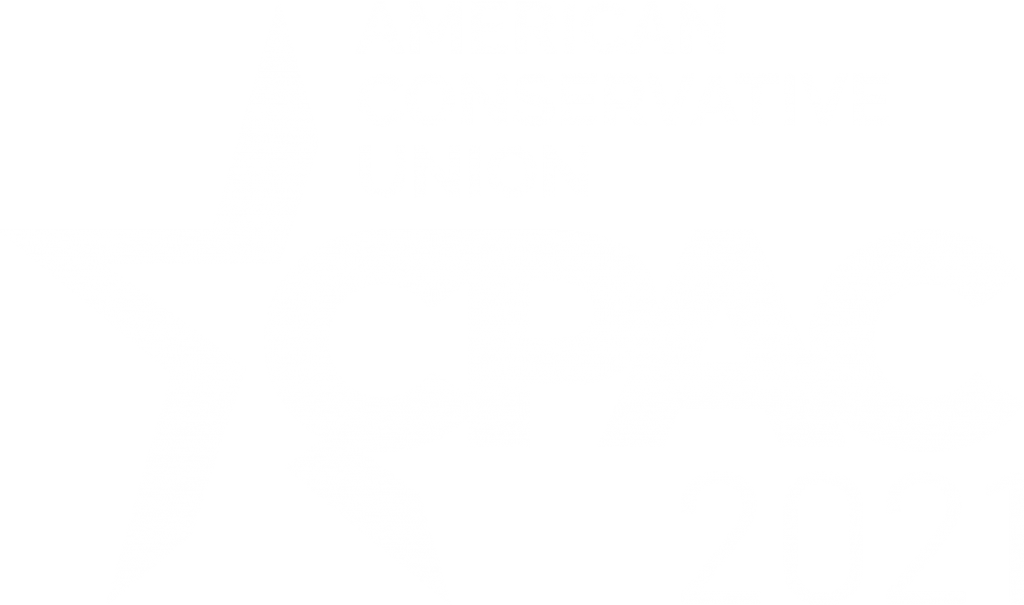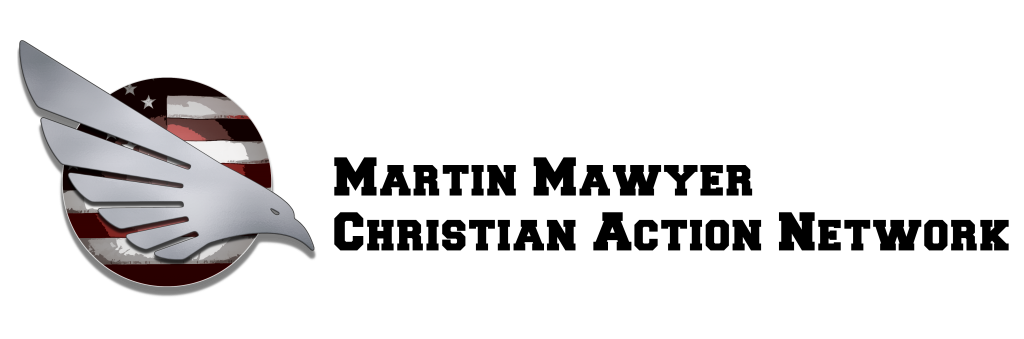La scuola italiana è cambiata molto negli ultimi dieci anni. E dall’anno scolastico 2011-2012 hanno fatto ingresso in classe, grazie a una legge bipartisan, il termine Bisogni educativi speciali (Bes) e la didattica che quei bisogni soddisfa. Prima dislessia, discalculia e disortografia. Poi, con una serie di aggiustamenti normativi, circolari, direttive, la definizione di un nuovo sistema di diritti degli studenti. Perché di diritti si parla. A non essere discriminati. A vedere riconosciuti i propri limiti ed essere per questo aiutati. Insomma, a non vivere la scuola come nemica. “Ricordo quando nei i consigli di classe si diceva: questo ragazzo è svogliato, fermarlo un anno gli farà bene”.
Antonio Matina, 57 anni, docente di inglese all’istituto tecnico-professionale Pier Crescenzi-Pacinotti-Sirani di Bologna, ha vissuto la scuola prima che la scuola si accorgesse dei ragazzi che avevano disturbi specifici di apprendimento e si parlasse di Bes. Una specializzazione nel sostegno lo ha aiutato negli anni ’90 a formarsi e ora è referente per il suo istituto per i Bes. “Ricordo che nel ’94, quando ho preso la specializzazione, i Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento, erano praticamente sconosciuti. Io stesso non insegnavo con le mappe concettuali.
Ora ne faccio largo uso, le costruisco con gli studenti. Quando devo spiegare la grammatica inglese, per esempio, realizzo uno schema insieme ai ragazzi in aula. E poi tanto lavoro di gruppo e verifiche personalizzate, dove magari eviti le domande aperte, scegli quelle a risposte multiple, o fai leggere a un compagno a voce alta la traccia di una prova. Un giorno per presentare i monumenti di Londra ho usato Google Earth e poi ho chiesto di lavorare per gruppi fingendo di dover fare le guide turistiche”.
Continua Matina: “Cambia il modo di insegnare e, alla fine, capisci che serve a tutti. Sono cambiato io, ma anche tanti colleghi. Oggi abbiamo strumenti e conoscenze che hanno fatto capire cosa è un Dsa, soprattutto alle superiori dove, nella maggior parte dei casi, passava il messaggio che erano studenti somari. Ora nei consigli di classe senti la collega che interviene dicendo “questo ragazzo ha delle difficoltà, dobbiamo aitarlo”.
Il designer Daniel Britton ha creato un font per aiutarci a comprendere meglio la dislessia
Intanto, le diagnosi di Dsa aumentano vertiginosamente. Lo rileva l’ultimo report dell’ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna. Si passa da 10.526 segnalazioni di Dsa nelle scuole, dalla primaria alle superiori, nel 2013, anno della prima rilevazione che fu pioniera in Italia, ai 32.966 dello scorso anno scolastico, il 2020-21. Con una crescita in questo arco di tempo del 213% e del 453% nei licei e istituti tecnici e professionali. Un dato che trova corrispondenza nei dati nazionali (ancorché fermi al 2019). Il numero degli alunni con Dsa sul totale dei frequentanti è salita dallo 0,8% dell’anno 2004/2005 al 3,1% del 2018-19 alla primaria, dall’1,6% al 5,9% alle medie e dallo 0,6% al 5,3% alle superiori.
“Anche noi assistiamo a un incremento di diagnosi”, osserva Simona Chiodo, direttrice della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl di Bologna. “Significa che l’attenzione sui disturbi dell’apprendimento è cresciuta: si conosce di più, si stigmatizza di meno. Il dato in questo senso è da leggere in positivo”. Con alcuni caveat. “Bisogna distinguere tra una difficoltà e un vero e proprio disturbo. Ogni bambino ha una sua linea di sviluppo, intervenire sulle fasi precoci permette di evitare conseguenze funzionali”.
Di qui, l’importanza degli screening precoci anche rispetto al picco che si registra di diagnosi tardive, che arrivano cioè nel passaggio dalle medie alle superiori, quando i ragazzi, magari aiutati prima dalla famiglia, non riescono più a stare al passo rispetto alle richieste della scuola. “C’è un protocollo con l’ufficio scolastico nella nostra regione che porta le scuole a fare prove in prima e seconda elementare in modo da intervenire subito. Il Dsa è un disturbo del neurosviluppo, ma con un buon allenamento qualcuno riesce a recuperare, si può scongiurare che una difficoltà si trasformi in disturbo. Noi medici non dobbiamo limitarci a una mera somministrazione di test neuropsicologici, ma fare valutazioni psico-diagnostiche per non patologizzare ciò che è educabile. Mentre i genitori dovrebbero abbassare le proprie aspettative sui bambini, la competizione spinta non li aiuta”.
Dai principi alle regole
La legge 170 del 2010 che garantisce e tutela il diritto allo studio per tutti gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e con bisogni educativi speciali (Bes), ha un prologo nei primi anni Duemila. È infatti del 28 marzo 2003 la legge (n.53) che, per prima, sancisce il principio della personalizzazione dell’insegnamento. L’obiettivo è, appunto, “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia”. Detta altrimenti, viene fissato l’obbligo che “l’apprendimento sia assicurato in tutto l’arco della vita e a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.
Solo qualche anno dopo, la legge 170 del 2010 declina il concetto di didattica inclusiva in una pratica effettivamente applicata nelle scuole. Vengono riconosciuti “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
In particolare, la dislessia viene definita come una “difficoltà nell’imparare a leggere, nella decifrazione dei segni linguistici, nella correttezza e nella rapidità della lettura”, la disgrafia come una “difficoltà nella realizzazione grafica” e la discalculia come una “difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri”. La legge 170 assegna inoltre alle scuole e alle università il compito di individuare sia le forme didattiche, sia le modalità di valutazione più adeguate affinché gli studenti Dsa possano raggiungere il successo formativo al pari degli altri compagni. Ma è attraverso il decreto attuativo del 12 luglio 2011 e le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento che vengono piantati i paletti definitivi e date alcune istruzioni operative alle istituzioni scolastiche su come muoversi in materia.
Gli strumenti
Le linee guida ministeriali prevedono alcuni strumenti didattici e tecnologici che possono essere utilizzati dagli alunni Dsa per compensare, appunto, i propri deficit nell’esecuzione di determinati compiti. La sintesi vocale, ad esempio, trasforma una verifica di lettura in una di ascolto. Il registratore permette allo studente di non dover scrivere gli appunti della lezione, mentre i programmi di videoscrittura con correttore ortografico consentono la produzione di testi sufficientemente corretti senza la fatica della rilettura. La calcolatrice facilita le operazioni, le tabelle e le mappe concettuali aiutano il ragionamento. Le misure dispensative danno invece modo allo studente Dsa di non svolgere alcune prestazioni rese particolarmente difficoltose dal disturbo da cui è affetto. “Per esempio – si legge nelle Linee guida – non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura”. Tra le misure dispensative, che devono comunque essere sempre valutate per non incidere negativamente sul percorso di apprendimento dello studente, ci sono le interrogazioni programmate, la concessione di tempi più lunghi per l’esecuzione di un compito o l’uso del vocabolario.
Nel dicembre del 2012, con una direttiva ministeriale, il Miur allarga il campo di applicazione della didattica inclusiva e introduce la definizione di alunni Bes (con bisogni educativi speciali). Tra di loro rientrano così anche tutti quegli studenti che hanno difficoltà di apprendimento non certificabili, ma comunque presenti. “L’area dello svantaggio scolastico – si legge nella direttiva – è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
Tutti questi studenti hanno diritto ad accedere a una didattica personalizzata. E se nei casi di disabilità e Dsa sono richieste certificazioni o diagnosi, in tutti gli altri è compito dei docenti identificare eventuali bisogni educativi speciali, che possono manifestarsi con continuità o per determinati periodi, basandosi sul modello Icf (International classification of functioning) dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Modello che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.
Per creare una rete di sostegno alle scuole sono stati istituiti anche i Cts, Centri territoriali di sostegno, istituiti dagli uffici scolastici regionali in accordo con il ministero dell’Istruzione e attraverso il progetto “Nuove tecnologie e disabilità”. I Cts rappresentano una rete pubblica e permanente di centri per gli ausili distribuita sul territorio (sono collocati all’interno di scuole polo e ce n’è almeno uno per provincia). Il loro compito è raccogliere e diffondere sia le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) sia le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica degli alunni Bes. La rete sostiene concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso delle nuove tecnologie per l’inclusione scolastica e offre consulenza sul tema a insegnanti, genitori e alunni. Infine, con la circolare ministeriale del 6 marzo 2013 vengono date ulteriori indicazioni operative alle scuole che estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
Un cambio di visione
La normativa sui Bes ha funzionato? Dario Ianes, docente di Pedagogia e didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano e co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento, non ha dubbi: “Ha funzionato, da un punto di vista ideale è stato introdotto nella scuola un concetto più equo, è stato fatto un passo nella direzione inclusiva. Ma ora occorre cambiare visione. Perché quello che occorre precisare è che siamo di fronte a non a una categoria clinica, ma politica. Si riconosce, cioè, una condizione di difficoltà che non ha solo origine biologica, ma che è condizionata dal contesto familiare e sociale e di cui la scuola inclusiva si fa carico. Insomma, ci si allontana da un modello bio-strutturale-medico”.
Per essere ancora più chiari, il professor Ianes attinge alla sua casistica: “Ricordo il caso di una bambina al quinto anno delle elementari: bravissima a scuola, educata, collaborativa. Ma per le maestre qualcosa non andava comunque perché vedevano che non frequentava le feste della scuola e i compagni. Hanno scoperto che il padre era in carcere e la madre agli arresti domiciliari e che dunque, abitando fuori dal paese, non aveva nemmeno autonomia negli spostamenti. Il suo bisogno educativo speciale era poter funzionare nella socialità, partecipare alle feste. La scuola ha così organizzato il trasporto con una cooperativa e quel bisogno ha avuto una risposta. Insomma, quando si parla di Bes significa capire cosa manca a ciascun alunno, comprendere ogni singola situazione a 360 gradi e rispondere sul piano didattico ed educativo a difficoltà che nella scuola bambini e ragazzi possono avere anche per matrici che non sono biologiche”.
Da BES a scuola – Ed. Erickson
Qualcosa, tuttavia, non ha funzionato. “Ci sono state alcune derive di medicalizzazione, che poi si rifanno a un sistema del welfare dove il riconoscimento di diritti fondamentali è ancorato a una diagnosi medica. Così si è arrivati a famiglie e insegnanti che chiedono una diagnosi di Bes che non esiste. Con il rischio, per altro, di una maggiore etichettatura. Per questo ora trovo necessario avviare una riflessione per fare un ulteriore passo avanti”. E quale debba essere è lo stesso Ianes a indicarlo. “Le forme di sostegno nella scuola, in termini di organici e risorse, non dovrebbero passare attraverso le diagnosi appiccicate a un bambino, ma dovrebbe essere la progettualità di una scuola in riferimento anche alla complessità del quartiere, del paese o città in cui opera, a far potenziare l’organico. Trovo, insomma, che collegare le risorse alle diagnosi sia un fattore distorsivo. Auspico un cambio di paradigma, una legge quadro dove si affermi che la scuola inclusiva è di tutti. Occorre ora decategorizzare, togliere le etichette e andare verso l’affermazione del concetto di differenza. Per una scuola che riconosce e valorizza tutte le differenze perché ogni alunno è speciale con la sua identità e la sua storia”.
“Non lasciamo soli questi ragazzi una volta finita la scuola”
Vittoria Franco, senatrice del Partito democratico per tre legislature, ricercatrice universitaria di filosofia, è stata la madre e prima firmataria della legge 170 del 2010. E nessuno meglio di lei conosce la strada che è stata fatta in questi dieci anni e quella che resta da percorrere. “Come spesso accade – ricorda – l’Italia era molto indietro su questi temi rispetto ad altri Paesi europei. Fino ad allora, la questione degli alunni Dsa era demandata alla discrezionalità delle scuole e alla buona volontà dei singoli insegnanti, non esistevano obblighi e tanto meno corsi di formazione. Nella quindicesima legislatura, con il governo Prodi, mentre ero presidente della Commissione cultura del Senato, fu presentato un disegno di legge sui Dsa e lo stesso fecero altre forze politiche. Non c’erano grandi differenze di pensiero, anzi fu semplice ottenere il consenso dei vari gruppi, solo che purtroppo i tempi si dilatarono troppo e con la caduta anticipata del governo cadde anche la possibilità di portare in fondo il progetto. Ci riprovammo nella sedicesima legislatura riproponendo lo stesso testo in accordo con un senatore di Forza Italia. Finalmente arrivò l’approvazione sia al Senato che alla Camera e, nel 2010, fu promulgata la legge 170”.
Dieci anni di applicazione della legge, conviene Vittoria Franco, hanno portato risultati importanti. “E – osserva – nel 2015, il libro Pensami al contrario di Daniela Conti e Anna Paris ce ne ha in qualche modo dato la riprova raccogliendo testimonianze di studenti e studentesse Dsa che hanno tratto vantaggio dalle nuove modalità didattiche. Oggi posso dire che sono due i principi fondamentali racchiusi nella legge che devono rimanere un faro: il diritto di tutti a raggiungere il successo formativo e il diritto al benessere. Mettere al centro lo studente, con la sua personalità e le sue differenze, valorizzandone le capacità”. Naturalmente, questi dieci anni di applicazione, non sono stati una passeggiata di salute. “Non è stato facile far passare nella scuola, per certi versi ancora molto ingessata e legata al passato, l’idea che l’utilizzo di strumenti compensativi o di misure dispensative non creasse un vantaggio per alcuni studenti rispetto ad altri, ma significasse invece uguaglianza delle opportunità. Alcuni insegnanti hanno continuato a non cogliere l’importanza della questione e a non voler dedicare tempo extra all’individuazione di piani didattici personalizzati. Penso, tuttavia, che sia solo un problema di cultura risolvibile con una maggiore diffusione di questi concetti e tanta, tanta formazione. Visto che i docenti sensibili e dediti a queste tematiche sono sempre di più”.
Qualcosa manca ancora. “Nel 2010, abbiamo necessariamente dovuto tener fuori dalla legge alcuni aspetti che ritenevamo fondamentali. Qualche passettino, da allora, è stato fatto. Penso ad esempio all’ultima norma sui concorsi pubblici che prevede, per i Dsa, una prova orale e l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative. Oppure la possibilità, per chi deve prendere la patente di guida e soffre di uno di questi disturbi, di avere dieci minuti aggiuntivi per lo svolgimento del test e un file audio nel caso abbia difficoltà nel leggere il testo. Quello su cui ora occorre andare avanti, a mio avviso, è una norma che disciplini l’inserimento lavorativo, perché una persona non smette di essere dislessica, anche se può apprendere tecniche per aggirare il problema. È importante non lasciare soli questi ragazzi una volta finita la scuola, perché potrebbero rivivere sul posto di lavoro lo stesso inferno che, qualche anno fa e prima della legge 170, avrebbero vissuto in classe”.
Quelli che no, “mio figlio non ha un problema, è solo un po’ immaturo”
E poi c’è chi dice no. Sono le madri e i padri che non accettano gli esami clinici, le valutazioni pedagogiche, i test, le diagnosi, i certificati dei loro figli con disturbi specifici dell’apprendimento o plusdotati. O, ancora, che vivono situazioni di disagio sociale, economico o culturale. Latitano dai colloqui con la scuola, rifiutano i piani di apprendimento personalizzato perché convinti di un’equazione: speciale uguale diverso e diverso uguale sbagliato, uguale malato, e dunque emarginato, escluso. Come se una valutazione di un esperto o l’individuazione di un bisogno speciale da parte del collegio di classe anche in assenza di deficit certificati fosse una sentenza di condanna. Non succede spesso, ma succede.
Racconta una maestra che vuol restare anonima per non violare la privacy del suo alunno: “Insegno in una scuola elementare e c’è un bambino che già dalla prima aveva qualche difficoltà nell’apprendimento e nella parola. Una difficoltà che non si sana, perché non è una malattia, non guarisce, ma se i bambini vengono aiutati possono avere risultati brillanti altrimenti i disturbi si accentuano davanti alla lettura e alla scrittura”.
I genitori vengono chiamati più e più volte a colloquio, fin dal primo anno. “Spiegare le fragilità dei figli a una madre e a un padre non è mai semplice, ma tra scuole e famiglie c’è un patto: dobbiamo aiutarci, altrimenti il sistema non funziona”, dice l’insegnante. A quella mamma e a quel papà gli insegnanti riferiscono le proprie osservazioni. Avendone in cambio questa risposta: “Nostro figlio è solo un po’ immaturo – ci dicono – non è ancora pronto, magari non è al livello degli altri ma insomma gli basterà esercitarsi un po’ di più”.
Camilla, studentessa Bes: ”Sto per laurearmi a pieni voti, al liceo mi dicevano stupida”
Camilla Coppola, 26 anni, responsabile del gruppo giovani dell’Aid (Associazione italiana dislessia) sta per laurearsi in giurisprudenza. Quasi nessuno a scuola si era accorto delle sue difficoltà, finché a 19 anni non le sono stati diagnosticati dislessia, discalculia e iperattività. Solo a quel punto, quando ha ricevuto la diagnosi di Dsa, ha trovato fiducia in se stessa e grazie a metodi alternativi di studio è uscita dall’incubo di nottate passate sui libri e brutti voti.
Intervista di Viola Giannoli e Giulia Santerini, riprese di Francis D’Costa e Leo Meuti, montaggio di Santiago Martinez
I maestri riescono a convincere i genitori a fare una valutazione da parte di un neuropsichiatra da cui emerge la necessità di un sostegno. Ma i genitori restano fermi nel loro “no”. “Abbiamo redatto un piano personalizzato, ma la famiglia non ha voluto firmarlo. Intanto il bambino è perso, legge male, non riesce a scrivere. Ci siamo spesi per aiutarlo, la maestra di sostegno presente in classe per assistere una altra alunna ha iniziato a seguirlo ma quando la famiglia lo ha scoperto si è offesa”, continua la docente che non si dà pace. Secondo il collegio di classe non è la bocciatura la strada migliore per colmare il gap. Anzi, si rischia di umiliare inutilmente. Ma se la famiglia si mette di traverso, diventa dura. “La scuola è questo: dare una mano a chi resta indietro più che promuovere solo i brillanti, quelli che ce la fanno da soli, ma ci siamo demoralizzati, non sappiamo come aiutarlo. Possiamo portare avanti il piano personalizzato comunque, ma le scelte della famiglia hanno conseguenze negative su loro figlio, è questo che io non posso accettare”, si sfoga ancora la maestra.
Viviana Rossi, ex docente alle elementari e alle medie, poi dirigente scolastica e formatrice dell’Aid, l’Associazione italiana per la dislessia, ricorda: “Ero appena diventata dirigente scolastica di una direzione didattica in provincia di Torino, quando arriva un papà di una quinta elementare a tempo pieno e mi butta sul tavolo la diagnosi di Dsa di suo figlio. ‘Ne faccia quel che vuole di questa’ mi dice. Allora io ho risposto ‘Beh, ne farò fare delle fotocopie per gli insegnanti, in modo che possano preparare per lui dei percorsi didattici personalizzati’. Quando ha capito che volevo usare quella diagnosi medica e condividerla con i docenti del figlio, si è spaventato ed è andato su tutte le furie: nessuno doveva sapere. Solo dopo molti colloqui, con il tempo e la pazienza, e l’aiuto della psicologa della scuola, lo abbiamo convinto a collaborare con gli insegnanti”.
Non c’è mai cattiveria, ma, in alcuni casi, negazione delle difficoltà dei propri figli e una scarsa conoscenza del disturbo specifico. “I genitori devono accettare le diversità, trasmettere fiducia ai loro figli, capire anzi che ognuno è differente e che in una scuola ideale ognuno dovrebbe avere un programma didattico personalizzato, ce lo dicono l’esperienza, la normativa vigente e anche le neuroscienze. “Nessuno di noi è uguale all’altro – spiega Rossi – Non è nascondendo i problemi o trasferendo il bambino in un’altra scuola o cambiandogli classe che si fa il suo bene”. Eppure “ci sono alcune famiglie che rifiutano strumenti compensativi e dispensativi”. O ragazzi, specialmente alle superiori, che potrebbero usare “il 30% in più di tempo durante i compiti in classe, pc, vocabolari online… ma non lo fanno perché vogliono essere tutti uguali, sentirsi uguali ai propri occhi e a quelli dei propri compagni, non venir privilegiati (anche se non si tratta di un privilegio ma di un diritto) e non finire oggetto di chiacchiere e sguardi. Ma, purtroppo, ci sono anche alcune scuole che negano a questi ragazzi il diritto a usare gli strumenti adeguati al loro disturbo specifico, soprattutto mappe e registrazioni anche se previsti dalla normativa”.
Paesi a confronto
Voci contro. “Non si deve medicalizzare la scuola”
Daniele Novara, pedagogista, educatore, definisce la scuola italiana, “la scuola delle etichette”. “Non è possibile che oggi in una classe un terzo dei bambini abbia una diagnosi da legge 104, una certificazione per Dsa, oppure, ancora, un’etichetta di Bes. E soltanto un gruppetto venga definito “normale”. Vi rendete conto che c’è qualcosa che non funziona?”. Anche perché, attenzione, se qualcosa non va, e su questo Novara è categorico, “Non è colpa dei bambini” dal titolo di uno dei suoi libri più famosi. Educatore e saggista Novara ha fondato a Piacenza il “Cpp”, Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Da anni porta avanti una tesi controcorrente rispetto alla “medicalizzazione” della scuola. Per Daniele Novara, al di là delle disabilità gravi vere e proprie, tutta la galassia che dai Dsa ai Bes attribuisce, “ai bambini, addirittura fin dalle scuole d’infanzia, disturbi e problematiche dell’apprendimento e del comportamento” altro non è che una resa dell’insegnamento contemporaneo alla burocrazia, un’abdicazione rispetto alla “funzione inclusiva della scuola”.
Spiega Novara: “L’Italia è il paese europeo che ha il maggior numero di alunni con diagnosi, il maggior numero di insegnanti di sostegno, un docente su quattro. Trecentomila ragazzi con handicap, 270mila con disturbi specifici dell’apprendimento, più un numero imprecisato di Bes. Questi numeri, che potrebbero far pensare ad una maggiore inclusività della nostra scuola, sono invece l’indice di una distorsione, di una sofferenza”. Piuttosto che aspettare lo sviluppo di un bambino immaturo, accogliere le difficoltà linguistiche di un’allieva immigrata, o la fatica nel concentrarsi di un adolescente, insomma, dice Novara, “si preferisce dare un’etichetta a quei bambini per non doversene occupare”, mentre la sfida dovrebbe essere portare avanti un gruppo classe nella sua interezza, anche se non tutti raggiungono lo stesso livello di competenze”.
Un vero e proprio atto d’accusa quello di Novara (a lungo collaboratore del sociologo pacifista Danilo Dolci) i cui libri sono seguitissimi così le sue conferenze sull’educazione e la gestione dei conflitti. “L’Italia è stata un paese all’avanguardia sull’inclusione della disabilità nei percorsi scolastici. Le classi differenziali furono abolite nel nostro paese nel 1977, ancor prima della chiusura dei manicomi voluta dalla legge Basaglia del 1978. La nostra istruzione primaria era un’eccellenza mondiale. Poi però quella grande spinta si è perduta, via via sono stati reintrodotti i voti, la frammentazione delle competenze, sono state smantellate nelle università le facoltà di Pedagogia. Siamo diventati la scuola dei traguardi e della competizione, e chi non riesce a stare al passo deve per forza avere qualcosa, bisogna inscatolare la sua difficoltà”.
Degli allievi ormai, ammonisce Novara, “non vengono valutati i progressi ma le mancanze, mentre è il percorso che dovrebbe essere premiati come diceva il maestro Manzi e prima di lui don Lorenzo Milani”. Nella scuola delle etichette, così la definisce Novara, l’ambito dei Bes, “è davvero quello più confuso, indefinito”. “Chi sono i Bes? Ragazzi in difficoltà per problemi linguistici, di inserimento. Non sono disabili, non sono Dsa, cioè dislessici, disgrafici o discalculici. E allora chi sono? Il bambino adottato che fa fatica a imparare l’italiano, quello che non riesce a concentrarsi, chi arriva da condizioni socioeconomiche sfavorevoli. C’era bisogno di una legge per definire questi alunni, con tutto il corollario di programmi personalizzati, verifiche facilitate, utilizzo di ausili in classe? Forse bastava l’intelligenza e la disponibilità di un corpo docente che non avesse abdicato alla propria funzione educativa”.
Già, ma chi li sopporta più i bambini difficili, quelli per cui ci vorrebbe più tempo, pazienza e tenacia perché imparino ad imparare? “Più facile mandarli dallo psicologo” dice amaramente Daniele Novara, che per queste sue tesi estreme e controcorrente si è fatto non pochi nemici. “Anche il mondo della neuropsichiatria sta facendo autocritica sull’eccesso di diagnosi. È un sistema che è andato ben oltre i giusti propositi inziali. Tra pochi anni, questo è il rischio, avremo classi dove ci sarà una minuscola élite di normali e tutti gli altri con una bella etichetta di Dsa, o Bes, appiccicata addosso”.
Esempio di dislessia
Fonte: AID Associazione Italiana Dislessia
Scardinare e innovare: la sfida della didattica per studenti Bes
Allargare lo spazio, scardinare il tempo, rivoluzionare il metodo. L’Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), con le sue ‘Avanguardie educative’ lanciate nel 2014, ha scosso la vecchia impostazione di fare scuola ancorata a un modello ancora Ottocentesco. E, facendolo, ha dato nuovi stimoli anche a tutti quegli studenti che soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento o che hanno bisogni educativi speciali. Li ha coinvolti, ascoltati, sganciati dall’immobilismo di alcuni insegnanti. “Siamo partiti con 22 scuole fondatrici – afferma Elisabetta Mughini, dirigente di ricerca Indire sull’innovazione del modello scolastico – e oggi la rete delle Avanguardie ne conta oltre 1280. Ci siamo accorti che il classico rituale per cui avveniva tutto in aula con la lezione frontale e i corridoi servivano solo per transitare, con la socializzazione ristretta al gruppo classe, finiva per escludere tanti ragazzi. Con l’introduzione di nuovi approcci, accompagnati ma non dominati dalle tecnologie, abbiamo visto che anche gli alunni Bes o con altri tipi di difficoltà riuscivano finalmente a emergere”.
Le metodologie non devono però essere intese come medicine, ma come interventi che il docente deve calibrare sugli studenti, magari alternandoli tra loro: “C’è il debate – spiega Mughini – strumento che permette di lavorare in gruppo e che sprona chi è più reticente nel parlare. Oppure c’è la routine Mltv (‘Making Learning and Thinking Visible, ovvero ‘Rendere visibili l’apprendimento e il pensiero nelle scuole) che attraverso una scansione del tempo coinvolge i ragazzi e li incoraggia a farsi delle domande in un approccio non trasmissivo ma collaborativo. O, ancora, c’è lo Spaced Learning (apprendimento intervallato) che parte dal principio scientifico per cui, soprattutto per ragazzi più fragili e che hanno fallimenti scolastici alle spalle, non si può creare un ‘overload cognitivo’ imponendo loro lunghe lezioni frontali, ma è preferibile alternare momenti di concentrazione ad attività pratiche che stimolano un’altra parte del cervello”.
Esempio di discalculia
Fonte: AID Associazione Italiana Dislessia
Indire lavora con una serie di scuole che manifestano una volontà di trasformarsi, le supporta, fa osservazioni sul campo e raccoglie le esperienze più efficaci traducendole in casi di studio da mettere a disposizione di tutta la comunità. “Oggi esiste la ‘Biblioteca dell’innovazione, una piattaforma aperta nella quale stiamo catalizzando tutte le buone pratiche attive nei vari territori e stiamo anche aggiornando, insieme al ministero dell’Istruzione, il portale dedicato ai Bes”, conclude Mughini.
“Siamo tutti diversi”: l’esperienza di Firenze
C’è una scuola, a Firenze, che ha fatto una scelta dirompente. L’istituto alberghiero “Buontalenti” ha deciso di formare classi composte interamente da ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, ai quali si aggiungono ragazzi che, per svariati motivi, hanno delle fragilità o non riescono ad andare avanti nel percorso dopo essere stati bocciati in altri istituti. Un’adesione volontaria, cercata dalle stesse famiglie. “Tutti noi siamo diversi – spiega la preside, Maria Francesca Cellai – e non è giusto omologare l’insegnamento. Ci siamo accorti che fare lezioni sempre uguali, con la canonica ora di spiegazione di storia o le equazioni alla lavagna, poteva non essere la giusta strategia per alcuni dei nostri studenti. Se tu docente pensi di insegnare le stesse cose nella solita maniera a tutti, rischi di danneggiare il ragazzo che non riesce a seguire, lo mandi incontro a insuccessi e frustrazioni. E certo non impara”.
È allora qui che scatta il sistema dell’apprendimento intervallato: “Non c’è più la tradizionale ora di storia o inglese di 60 minuti, ma un momento formativo diviso in tre parti. Nella prima fase il docente spiega, ad esempio, la Prima guerra mondiale con il metodo classico frontale. Poi c’è una pausa di dieci minuti durante la quale i ragazzi si alzano liberamente e possono andare fuori a fare degli esercizi di educazione fisica, oppure compilare un cruciverba, fare degli origami con la carta o persino raggiungere la cucina per preparare un piatto. Questo stacco serve a stimolare una parte diversa del cervello rispetto a quella usata durante la spiegazione standard, ad abbinare all’ascolto alcune attività pratiche. Dopodiché è il momento di tornare a parlare della Prima guerra mondiale, ma tocca agli studenti prendere in mano la lezione e dire all’insegnante quello che hanno compreso per consolidare le informazioni ricevute all’inizio. Infine, è previsto un questionario aperto così che l’insegnante possa vedere immediatamente se il ragazzo ha compreso, ma i compiti in classe sono aboliti visto che nei ragazzi Dsa o Bes questi generano ansia e c’è il rischio di ottenere l’effetto contrario”.
Esempio di disortografia
Fonte: AID Associazione Italiana Dislessia
Non c’è però il timore che questi studenti si isolino sempre più e possano sentirsi ghettizzati? “Nella nostra scuola sono tanti quelli che rimangono indietro – afferma Cellai – e se prima non si sentivano capiti da nessuno, ora ci raccontano di essere valorizzati. Abbiamo visto risultati importanti, progressi significativi in materie come inglese e italiano, ma soprattutto li vediamo star bene, essere entusiasti di venire a scuola mentre prima avrebbero solo voluto che la sveglia la mattina non suonasse più”.
“L’uno spalla dell’altro”: debate a Loreto
Addio competizione e stop alla solita didattica con il capo chino sul banco che può mettere a disagio chi ha difficoltà nello scrivere, nel leggere o anche semplicemente nel concentrarsi su un libro di testo statico. Gli insegnanti dell’istituto comprensivo “Giannuario Solari” di Loreto (Ancona) hanno trovato nel debate un ottimo strumento per migliorare il coinvolgimento di tutta la classe e soprattutto valorizzare gli alunni con bisogni educativi speciali. “I ragazzi (e i bambini visto che applichiamo questa tecnica fin dalla primaria) diventano l’uno la spalla dell’altro, collaborano e si ascoltano, abbattono le barriere e superano la frustrazione di non essere capaci in certe materie” spiega Giulia Monaldi, docente di italiano, storia, arte e inglese.
Ma come funziona? “Di solito, per favorire il loro interesse, scegliamo di partire da un tema extra-disciplinare che sentono vicino, come possono essere le vacanze, il calcio, un videogioco, il paese in cui vivono. Poi proponiamo un ‘brain-storming’ durante il quale sono liberi di esprimere le proprie idee, sia i pro che i contro. A quel punto li dividiamo in piccoli gruppi di lavoro nel corso dei quali approfondiscono alcuni esempi pratici e poi organizzano un breve discorso. Dopo essersi esercitati per qualche minuto lo espongono alla classe e si arriva al momento finale del dibattito. È un sistema – continua Monaldi – che aiuta soprattutto chi ha difficoltà nella scrittura o chi di norma ha timore nel prendere la parola, ma ne trae giovamento tutta la classe. In pratica trasformiamo l’esposizione di un concetto in un’attività ludica e senza giudizio e la cosa più bella è che si innesca sempre un forte processo empatico”.
La squadra di debate al comprensivo Giannuario Solari di Loreto (Ancona)
Ma c’è un’altra strategia, anche questa estesa all’intera classe, che sta dando ottimi risultati in particolare sugli alunni dislessici: “Si tratta, in gergo, di un’attività routinaria, e consiste in esercizi propedeutici di tipo teatrale – specifica Monaldi – lavoriamo molto sull’aspetto non verbale e paraverbale, utilizzando la gestualità, la postura e lo sguardo. Incredibile osservare quanto bambini normalmente timidi e chiusi si lascino andare alla libera espressione”.
A Udine con uno sguardo su Harvard
“Rendere visibili l’apprendimento e il pensiero nelle scuole”. È con questo motto che l’Istituto di istruzione superiore “Arturo Malignani” di Udine, condividendo esperienze dell’Università di Harvard e lavorando a stretto contatto con Indire, si impegna ogni giorno a scardinare le vecchie regole del fare scuola. Un modo per far emergere le potenzialità di tutti gli studenti, nella loro diversità di caratteristiche. “Come docenti siamo partiti da una domanda: ‘Che cosa vale la pena insegnare in un mondo complesso che sta cambiando?'”, spiega Raffaella Tomasini, professoressa al Malignan. Il metodo Mltv si concentra sul pensiero e su delle attività routinarie nelle quali gli studenti si attivano, osservano, raccolgono materiale, lo analizzano e lo restituiscono al resto della classe attraverso il confronto. Non a caso la scansione è questa: ‘See, think, wonder’ e cioè ‘Osserva, pensa e fatti delle domande’.
Un esempio? “Mostriamo un’immagine agli studenti, che può essere un quadro, la copertina di un libro o la foto di un giornale, chiediamo loro di guardarla e di dirci cosa vedono, ma senza cercare di interpretarla o di fare ipotesi. Solo dopo arriva il momento di rivelare cosa pensano che stia accadendo, ma a questo punto si tratta di riflessioni basate su ciò che hanno visto e quindi fondate. Poi l’ultima parte consiste nel farsi delle domande su ciò che ancora non è chiaro lavorando in gruppo”. Ma come si realizza l’inclusione e soprattutto la partecipazione di tutti, anche degli alunni Bes? “C’è un’operazione preliminare, che consiste nello stabilire insieme le regole di lavoro del gruppo – sottolinea Tomasini – a decidere non è un unico studente o gli insegnanti, ma si innesca un vero processo di negoziazione. Chiediamo a ciascun ragazzo di pensare alle regole che, secondo lui, lo farebbero star bene in un lavoro collettivo. Poi li facciamo confrontare a due a due e ogni coppia, dopo averne parlato, deve scegliere tre regole condivise. E avanti così fino ad avere solo tre regole finali per tutta la classe. Questo metodo unisce e responsabilizza i ragazzi e, soprattutto, spinge ad ascoltare i bisogni di tutti”.
Esempio di disgrafia
Fonte: AID Associazione Italiana Dislessia
La “Contamination School”
L’istituto “Pavoniano Artigianelli” di Trento assomiglia più a un’università che a una scuola superiore. È una piazza nella quale tutti cooperano per generare apprendimento: c’è un istituto di istruzione professionale, un percorso di alta formazione grafica, un laboratorio accademico di innovazione, due cooperative, una multinazionale di cartoni animati e uno stretto legame con varie realtà aziendali e centri di ricerca e innovazione. Al posto delle classiche materie ci sono dei corsi, moduli che ciascun ragazzo sceglie e attraverso i quali ruota senza rimanere ancorato alla stessa aula. “Abbiamo notato che la catena di montaggio standard fatta dal suono della campanella, da classi chiuse, dalle lezioni frontali seduti davanti alla cattedra non riusciva più a rispondere alle esigenze di tutti i ragazzi e, soprattutto chi aveva delle difficoltà, veniva buttato fuori “, afferma il dirigente scolastico, Erik Gadotti. “Così abbiamo cercato di creare un nuovo paradigma non tanto per integrare qualcuno, ma per valorizzare tutti”.
C’è il ragazzo che ha bisogno dell’approccio più tradizionale e quello che invece rende meglio con un insegnamento più interattivo e così ogni corso (alcuni sono opzionali, altri obbligatori) si differenzia sia per livello di complessità che per metodologia: “Ciascun alunno può così costruire il proprio curriculum in modo da sperimentare sempre il successo formativo – aggiunge Gadotti – chi è bravissimo in letteratura o scrittura ma fa più fatica in matematica frequenterà il modulo avanzato del primo e quello base per il secondo così da consolidare gli apprendimenti in un percorso personalizzato guidato dagli insegnanti”. Una tecnica, quella della ‘Contamination School’, che sta funzionando molto per gli alunni Dsa e Bes, i quali sperimentano approcci diversi nell’apprendimento di italiano, matematica e inglese e hanno modo di sviluppare anche altre competenze creative e pratiche: “I ragazzi risultano più motivati e anche i loro risultati migliorano progressivamente – conclude il preside – l’obiettivo è costruire una didattica equa per l’intero mondo studentesco e, grazie all’attenzione per chi ha più difficoltà, ci siamo ritrovati in una scuola che è risultata migliore per tutti, anche per i più bravi”.
L’istituto “Pavoniano Artigianelli” di Trento
I portatori di handicap e l’importanza di coinvolgere tutti
La professoressa Cristina Maola, 55 anni, due figli, un marito primo trombone al Teatro San Carlo di Napoli, è da sempre una docente di sostegno. Per scelta. Romana, insegnante di Educazione fisica, dal 1997 è di ruolo. A Caserta. E negli ultimi 24 anni ha insegnato – “perché io, insegnante di sostegno, sono un’insegnante” – sempre nella stessa scuola: l’Isiss Righi Nervi Solimena di Santa Maria Capua Vetere. “Avrei potuto chiedere il passaggio di materia anni fa, ma questo, il sostegno, ormai è la mia professione”. La affianca allo sport. È stata nel Comitato italiano paralimpico, si è occupata dei disabili gravi. È vicina alla Cgil, che a scuola si chiama Flc.
Ogni mattina un pensiero fisso accompagna la professoressa Cristina Maola in viaggio verso scuola: “Speriamo di portare un risultato positivo”. Significa: “Quando i ragazzi stanno bene, quando sorridono, noi dimentichiamo tutto. Nella quotidianità ci accompagna un continuo senso di solitudine, ma appena entriamo in classe dimentichiamo i problemi. Abbiamo la percezione che siamo la luce per loro, i nostri ragazzi fragili. Si affidano a noi”. Il risultato positivo, che precede il sorriso, è riuscire a insegnare una cosa, qualsiasi cosa – “un principio di libertà, la risoluzione in autonomia di un’equazione di primo grado” -, a studenti con un handicap. L’Istituto di istruzione secondaria superiore di Santa Maria Capua Vetere, insieme al liceo artistico, ospita più di 600 alunni: aspiranti geometri, odontotecnici, ottici, elettricisti, elettrotecnici, futuri donne e uomini della moda. Settanta di loro, uno ogni nove, hanno un Bes assegnato. I titolari del sostegno ci sono: trentadue di ruolo, più quelli che arriveranno per il potenziamento. “Ogni anno chiediamo un numero di ore che, puntualmente, ci viene tagliato”.
La professoressa Maola nel 2021-2022 ha due casi assegnati, in due classi diverse. Più altre due copresenze: vuol dire che su questi studenti lei non è da sola. Tutti e quattro i ragazzi usufruiscono della Legge 104, quella varata nel 1992 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Sono comma 1: non hanno disabilità, motorie o intellettive, gravi. Ma vite da ricostruire. Lo studente da seguire con priorità, ora in seconda, la professoressa lo conosce: hanno fatto insieme già un anno. È inserito nella programmazione della classe di Meccanica, ma ha un difficile rapporto con i compagni. “Il nostro lavoro è fargli capire che esiste un’altra vita possibile oltre quella che ha conosciuto fin qui”. Non vive più con la famiglia naturale.
Lei, l’altra ragazza assegnata, è al quarto anno di Moda, ma è a rischio dispersione scolastica. La Didattica a distanza ne ha sfiancati diversi. È poco interessata alla scuola, l’insegnante Maola già sa che non si presenterà in questo avvio di stagione. Se la studentessa seguita non si vede in classe, alla fine delle lezioni la docente di sostegno avverte la famiglia. Poi detta un fonogramma alla dirigente scolastica. Padre e madre vengono convocati, se non hanno il Green Pass per entrare a scuola si allestirà una videochiamata. No, l’insegnante di sostegno non va a casa delle famiglie: “Non sono un’assistente sociale, sono una docente. Un’altra cosa”. In aula Cristina Maola segue i due, ma in verità segue l’intera classe: “Tutti hanno bisogno di sostegno, anche noi docenti. Tutti abbiamo bisogno di assistenza psicologica, ma siamo spesso lasciati soli”. A proposito del senso di solitudine. “Servirebbe un centro d’ascolto per ogni istituto”.
Con la docente di Moda c’è uno stretto rapporto: “Siamo amiche, dobbiamo accogliere tutta la classe, crediamo nella didattica di gruppo”. Con il docente di Educazione motoria, disciplina su cui Cristina Maola è specializzata, spesso si scambia il ruolo. La qualità di un insegnante di sostegno, è convinta, sta nella capacità di osservare senza far sentire il ragazzo da seguire al centro di un’attenzione controproducente. “Nelle classi io non ho la cattedra, non ho un banco fisso. Mi siedo dove c’è posto. Ascolto la lezione, prendo appunti: velocemente passo i concetti all’alunno che seguo. Se non ha problemi di comprensione, nel pomeriggio gli invio su WhatsApp contenuti e schede”. Se nel ragazzo coglie disinteresse, la professoressa Maola usa il cambio d’ora per parlargli: “Questo se il rapporto è consolidato”. Se c’era qualcosa che non andava, lo rivedono insieme.
Quando deve sostituire una collega di materia assente – sì, ci sono anche le supplenze per un’insegnante di sostegno di ruolo – “faccio una lezione di sostegno a tutta la classe”. Durante Fisica o Meccanica, invece, Maola va alla lavagna e aiuta il collega che spiega disegnando schede, mappe, parole chiave. Poi condivide su WhatsApp. Se il ragazzo assegnato disturba? Si fa aggressivo? “Intervengo subito. Se la situazione mette a rischio lo studente, devo bloccarlo, calmarlo”. Ha avuto di recente un handicap grave da seguire, “ho preso più volte degli schiaffi”. Una ragazza usava le matite come coltelli, rompivetri. “Io la fermavo e iniziavo a parlarle nell’orecchio. Si calmava”. La docente romana offre il suo sostegno anche a chi non rientra nella sfera dell’handicap. “Quando sono in classe la mia professione si sdoppia. In generale il nostro atteggiamento è inclusivo e la nostra missione quella di combattere la dispersione scolastica”. C’è chi, tra i suoi alunni, ha una difficoltà titanica a concentrarsi, chi non riesce a mettere in fila i numeri – discalculia -, chi è accompagnato da forme lievi di autismo. “Creiamo gruppi di lavoro mettendo insieme chi è seguito e chi no, quello che va bene per gli alunni bisognosi di sostegno deve andare bene per tutti”. I ragazzi Bes più capaci fanno da tutor agli altri: “La priorità è quella di portarli, tutti, all’Esame di Stato”. La Maturità.
Questi alunni sono concentrati negli istituti professionali, “i percorsi didattici dei licei sono più difficili per loro”. Le disortografie e le disgrafie non si possono correggere, sostiene: “Noi lavoriamo su come consentire un successo formativo con la presenza deficit, difficilmente eliminabile. Non siamo riabilitatori, noi lavoriamo sulle loro capacità residue. Se un alunno ha un problema di calcolo non insisto, userà la calcolatrice. Se ha problemi di lettura, devo aiutarlo con testi più grandi, ma non andrò mai a correggerlo. Si lavora su quello che sanno fare. Spesso questi ragazzi hanno un problema della memoria di lavoro, è molto breve: non bisogna sovraccaricarli se no cade la concentrazione”.
La storia di Giada: “Padre in carcere, famiglia assente. Così la scuola l’ha salvata”
Giada è una ragazzina della periferia nord di Roma. Suo padre è in carcere. Sua sorella ha 18 anni, ed è già mamma. Una famiglia complicata. A scuola Giada è aggressiva con professori e compagni, e non vuole studiare. I suoi insegnanti – dell’Istituto comprensivo Maria Montessori di viale Adriatico – decidono di aiutarla con un perscorso didattico personalizzato. Una scelta che la salverà. “Senza un programma speciale si sarebbe persa, avrebbe abbandonato la scuola”, raccontano i professori. Invece Giada è riuscita a prendere il diploma di scuola media e frequenta un corso professionale regionale. Oggi è più serena.
Servizio di Valeria Teodonio, riprese di Francis D’Costa, Leo Meuti e Alessio Pasquini, montaggio di Lorenzo Urbani
Nell’era di Tik Tok e dei video straripanti, il Bes più diffuso tra gli studenti è l’incapacità di concentrarsi. Si chiama Adhd: Disturbo da deficit di attenzione. “Gli alunni di oggi si stancano rapidamente, più rapidamente. Tutto e subito è il problema. Noi, da studenti, riuscivamo a leggere e memorizzare più pagine, loro hanno bisogno di continue pause. Non solo quelli del sostegno”. La dipendenza dal cellulare è diventata la priorità da affrontare, “non ne possiamo più”. All’Isiss di Santa Maria Capua Vetere sono arrivati a fare azioni di disintossicazione: “Mettiamo lo smartphone nella scatola e chiediamo ai ragazzi: “Vediamo quanto siete capaci di stare senza””. Cinquanta minuti senza, una sofferenza: “Sembravano in crisi di astinenza”. In questo racconto s’intravvede la caduta della parola, del suo significato, del suo utilizzo, in un mondo contemporaneo dominato dall’immagine: “I ragazzi scelgono un altro modo di comunicare, non passano per il linguaggio”.
Sono meno abituati al contatto fisico, e qui il discorso si allarga a un’intera generazione. “Sono molto timidi. Io parlo guardandoli negli occhi, loro non ce la fanno”. Il giudizio sui social è illuminante: “Noi adulti impariamo a usare il loro mezzo, lo smartphone, e riusciamo a dominarlo perché è l’ultimo di una serie, libri, giornali, radio, tv. Loro vengono soggiogati dai protagonisti di quello strumento, i social media. Il linguaggio povero che utilizzano, almeno questo riscontro nel nostro istituto professionale, lo testimonia. Dobbiamo allenarli ad argomentare i contenuti. Quando facciamo un’analisi del testo, la maggior parte dei ragazzi non riesce a capire qual è il messaggio. Allora frammentiamo le frasi, ma loro si stancano a seguirle”.
Lo studente border line, quello con il disagio della sfera emotiva e della relazione, è diventato il migliore della sua classe, in prima. “Gli abbiamo insegnato a partecipare”. Lei, quella che non vuole affrontare la quarta, ha una programmazione differenziata, diversa dal resto del gruppo: “Vorrei convincerla a integrarsi e a integrare i contenuti”. Essere docente di sostegno vuol dire subire il mobbing dei colleghi, a volte.
“L’atteggiamento snobistico di chi ha una materia piena, curricolare, esiste. Sono finita sotto consiglio disciplinare a mia insaputa, e sono stata assolta, per aver difeso la mia professionalità e prima ancora l’alunno. Una collega aveva messo su un film di fantascienza, poi la preside si è resa conto di come stavano le cose. Questa brutta esperienza è figlia dell’ignoranza del mio lavoro, spesso gli altri docenti contribuiscono a complicarlo”. Dopo cinque anni l’insegnante specializzato sul sostegno può passare sulla cosiddetta materia: “È un lavoro che non possono fare tutti e, certo, il sostegno non può essere un grimaldello per entrare a scuola, per fare punteggio. Lo si deve scegliere con convinzione”.
Ci sono due problemi generali e centrali: un susseguirsi di normative e aggiornamenti di normative, “lo subiamo dal 1992 e siamo arrivati al dicembre 2020, decreto interministeriale discutibile”. E poi a scuola si vedono davvero poco i funzionari delle Aziende sanitarie locali. “Dovremmo fare riunioni almeno due volte l’anno, ne facciamo una e sempre sul finale di stagione”. Un bel problema: “Ci aggiorniamo da soli, ogni volta siamo noi che spieghiamo ai colleghi il Piano educativo individualizzato. Ogni anno partiamo e non abbiamo i profili di funzionamento, le Asl si vedono poco”.