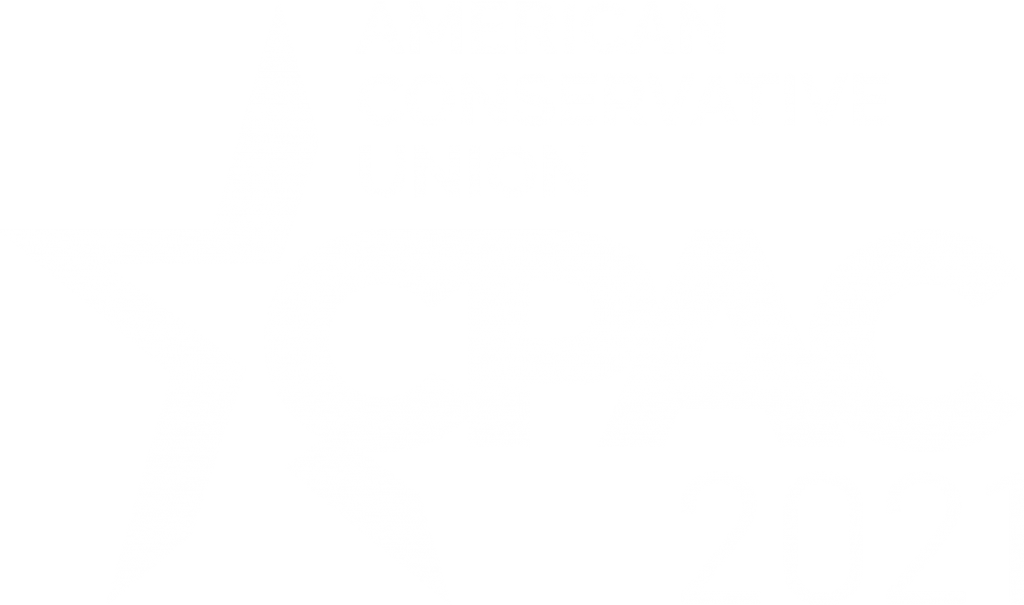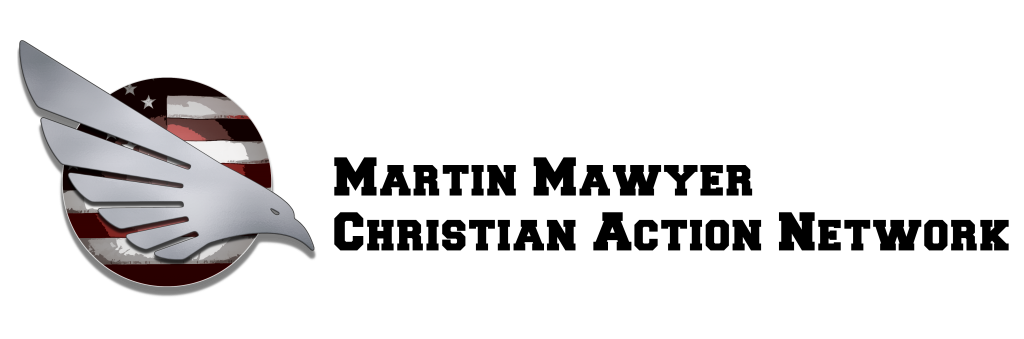La musica arrivava a folate, ogni volta che si apriva la porta della società ginnastica “Sempre Avanti!”, e per un po’ sembrava rimanere sospesa tra il buio e il gelo della notte bolognese di Capodanno. Si bussava alla palestra del liceo Minghetti, concessa dal preside con l’unica preghiera di evitare incidenti: per questo si poteva entrare soltanto con uno speciale biglietto d’invito nominale, rilasciato dalla Lega Proletaria Mutilati, e vicino al buffet con lo spumante vigilava dalla poltrona l’agente di polizia Allegretti, mentre due guardie regie pattugliavano dalle 9 l’esterno, spiegando ai curiosi che era una festa privata di un’associazione di invalidi, con pesca di beneficienza per gli orfani di guerra.
Benito Mussolini in piazza del Popolo con i quadrumviri e altri stretti collaboratori
I bambini del quartiere attirati dagli addobbi luminosi e dai festoni verdi si schiacciavano contro la finestra, le madri erano scese prima di mezzanotte a chiamarli e poi si erano fermate nella strada ad ascoltare l’orchestra che passava da Come pioveva a Scettico blues, a Cara piccina e Addio Tabarin, a Come le rose, Alcova e finalmente a Vipera, che tutti aspettavano, finché il cantante confessò al microfono: “M’avea già morso il cuore”.
I fascisti arrivarono pochi minuti prima delle due, protetti dal botto dei petardi nelle vie e nei cortili, mentre i balli erano ripresi dopo il brindisi. Da dentro giungevano le note morbide e i versi innocenti di Abat jours, ma un colpo di pistola nella strada fermò la musica. “Aprite, o sarà peggio”. Qualcuno aveva sparso la voce che nella palestra a mezzanotte in punto era stata intonata L’Internazionale, come augurio per il nuovo anno. Gli squadristi, radunati al “Caffè del Centro” in via San Gervasio, non potevano tollerarlo, e decisero subito una spedizione. Adesso erano qui fuori. “Aprite, è un ordine”.
Nella palestra avevano chiuso subito la finestra e sprangato la porta, puntellata con una scala. Gli spari di pistola e i colpi di moschetto risuonavano in via Maggia, una “ballerina”, come chiamavano la bomba a mano Thévenot, scoppiò nel cortile del liceo sostituendo la paura alla festa, le spallate continuavano violente fino a quando la porta cedette, sfondata, e gli assalitori entrarono seguiti da una pattuglia di guardie regie che era arrivata in bicicletta.
Bastonate agli uomini, schiaffi alle mogli, spintoni alle ragazze, il manganello che colpiva la testa, le braccia, le spalle, con i bambini che urlavano e i militari che perquisivano i soci della Lega Proletaria a mani alzate contro il muro. Quindici feriti, tre comunisti e due socialisti ricoverati all’ospedale Maggiore, vetri rotti dappertutto, premi della lotteria spariti, cappotti e cappelli sequestrati, ventitré fermi di polizia, nell’aria impaurita l’odore di polvere da sparo. Con centocinquantun bossoli per terra finiva la prima notte di gennaio e cominciava il 1922 italiano, l’anno del fascismo.
L’uomo che diventerà Duce ha 38 anni e mezzo, una moglie sposata nel 1915 con rito civile, tre figli ufficiali e uno fuori dal matrimonio a cui ha dato il suo stesso nome, Benito, e ha appena attraversato mesi in cui tutto quel che aveva costruito sembrava scivolargli dalle mani, disperdendosi. Il fascismo è giovane, nato appena tre anni prima, e ha compiuto i suoi primi passi con fatica. Ma il suo inventore ha passato momenti più difficili che gli tornano in mente proprio in quei giorni, nel bilancio di Capodanno. Espulso due volte dalla Svizzera, arrestato per vagabondaggio e in seguito come agitatore socialista, in carcere a Bologna con Pietro Nenni per le manifestazioni contro la guerra di Libia: poi, dopo la direzione dell’Avanti!, la cacciata dal partito per la conversione all’interventismo, la fondazione del Popolo d’Italia e la creazione dei Fasci di Combattimento nell’adunata di piazza San Sepolcro a Milano, nel salone del Circolo degli interessi industriali, con i giornali scettici o distratti nonostante il giuramento dei fedelissimi sul pugnale scintillante del capitano Ferruccio Vecchi: “Pronti a uccidere e a morire per difendere l’Italia dal nemico interno”, per “demolire il bolscevismo”, per “dichiarare guerra al socialismo”.
Il primo numero del Popolo d’Italia diretto da Benit Mussolini: 15 novembre 1914
Ma il momento più cupo è quello delle elezioni politiche del 1919, coi socialisti che trionfano come primo partito e raggiungono più di un milione e 800 mila voti, mentre i Fasci ne raccolgono appena 4657, (Mussolini poco più di duemila) e non portano nemmeno un deputato in parlamento. Sembra finita, col movimento soffocato nella culla e il suo Duce tentato di abbandonare la politica e vendere il giornale per fare l’attore, o il pilota di aerei, oppure girare il mondo col violino: mentre i socialisti inscenano il funerale goliardico del fascismo per strada a Milano, con la bara di Mussolini che precede quelle di Gabriele D’Annunzio e di Filippo Tommaso Marinetti, bocciato nelle urne nonostante il clangore immaginifico delle sue trasfigurazioni futuriste. Una notizia pubblicata sull’Avanti! il 18 novembre 1919 annuncia che “un cadavere in istato di avanzata putrefazione fu ripescato stamane nel Naviglio: pare si tratti di Benito Mussolini”.
Quello stesso giorno lo arrestano, per l’undicesima volta, dopo aver trovato una provvista di pistole, proiettili e ordigni in un armadio del “Covo”, la sede del Popolo d’Italia a Milano, in via Paolo da Cannobio 35, con un fucile appeso al muro. Subito rilasciato, costruirà la sua rivincita con l’azzardo, il fiuto politico, la tattica spregiudicata, l’opportunismo, l’abilità manovriera e soprattutto la violenza, incrociando lo spirito del tempo, svelando la guerra non come una parentesi ma come una frattura tra due epoche, e proponendo al Paese il fascismo come prodotto della crisi e contemporaneamente come sua interpretazione, chiave di lettura e soluzione d’impeto radicale.
Il “Covo”: la prima sede del Popolo d’Italia in via Paolo da Cannobio a Milano
In questo senso Mussolini, con la sua concezione tragica e spettacolare della vita, è istintivamente pronto più di tutti a cogliere la modernità drammatica della fase, con il tempo che non scorre più lineare ma si rompe proprio sulle illusioni e le frustrazioni della generazione bellica, smarrita e sbalestrata dopo la sua esperienza estrema: ed è primitivo invece nel ricorso ancestrale alla forza come strumento di sopraffazione più che di supremazia, riducendo la politica a una dimensione fisica, la lotta a prepotenza, con la brutalità che sostituisce l’egemonia e la ritualità che soppianta la cultura.
Attorno, un cielo vuoto di stelle spente, in un mondo politico in disfacimento incapace di leggere la società in trasformazione, frastornato dall’eco mondiale della rivoluzione bolscevica e dalla suggestione contagiosa che il mito della Russia irradiava da San Pietroburgo: si parlava sottovoce di Trotzkij, si leggevano ogni giorno notizie sulla carestia sovietica, si raccontava che a Belgrado il granduca Cirillo si era appena proclamato Zar della Russia. Lo Stato liberale italiano sembrava esausto e non lo sapeva, incapace di fronteggiare i nuovi fenomeni sociali e politici, come se non rientrassero più dentro le sue categorie antiche. Anche l’esperienza scettica di Giolitti pareva consumata, mentre si ostinava ad attendere che il corso naturale delle cose incanalasse l’urto delle novità dentro l’alveo istituzionale, dove il sistema avrebbe provato ancora una volta ad assorbirle, costituzionalizzandole e neutralizzando ogni carica eversiva.
I popolari erano ai primi passi, dopo il “Non expedit” che con decreto della Sacra Penitenzieria vaticana, nel 1874, aveva fatto divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica dello Stato italiano fino al 1919, quando papa Benedetto XV permise ai fedeli di aderire al partito di don Luigi Sturzo. I comunisti ubbidivano direttamente a Mosca attraverso il canone della Terza Internazionale, i socialisti li inseguivano dopo la scissione di Livorno del 1921, e al congresso di Bologna intanto avevano cancellato l’ispirazione riformista su cui il partito era nato a Genova alla fine dell’Ottocento, sostituendola con l’obiettivo della “repubblica socialista” e della “dittatura del proletariato”, da raggiungere “dovunque, con l’abbattimento violento del dominio capitalista borghese”, perché “il proletariato deve ricorrere all’impiego della violenza per difendersi e per consolidare le conquiste rivoluzionarie”, sostituendo i Soviet di contadini, operai e soldati alle istituzioni borghesi.
Proprio la Russia, con la figura leggendaria di Lenin, spaventava la borghesia italiana, terrorizzava gli agrari, inquietava gli industriali che vedevano nelle loro fabbriche il luogo predestinato della sovversione proletaria, dove poteva essere sparso e custodito il seme della rivoluzione mondiale e indigena, con Antonio Gramsci che teorizzava sull’Ordine Nuovo i Consigli operai come i Soviet italiani, nucleo del futuro Stato dei lavoratori. E l’occupazione delle fabbriche di fine agosto e settembre 1920 era sembrata a tutti una prova generale, capace di far precipitare dentro il recinto delle officine in mano alle Guardie Rosse le paure e le attese di un Paese che avvertiva confusamente di essere sull’orlo di qualche evento eccezionale.
Fu quella l’ultima volta che l’arte di governo di Giolitti riuscì a controllare la dinamica degli eventi, respingendo la pressione degli industriali perché impiegasse le truppe contro l’occupazione, drammatizzando lo scontro. Al contrario, il presidente del Consiglio puntò sulla diplomazia più che sull’artiglieria, normalizzando ciò che appariva straordinario, fino al punto da mostrarsi in vacanza a Bardonecchia al culmine dell’emergenza, passare da casa a Cavour, visitare il collegio a Dronero, dove si stava già preparando il banchetto per il suo ottantesimo compleanno, con la banda alla stazione, servizio speciale del tramvai, vermouth in municipio e padiglione d’onore sotto l’ala del teatro. Ma anche Giolitti non si rese conto che la sua tattica era invecchiata con lui, e non funzionava più, perché queste sollecitazioni terminali del meccanismo istituzionale lasciavano qualcosa di incognito e sospeso nel sentimento del Paese, come se ogni volta si forzasse il limite in cui vive lo Stato, logorandolo nell’evidenza ripetuta della permeabilità del sistema di fronte alla furia dell’epoca nuova che premeva alle sue porte.
È esattamente qui che s’infila Mussolini, a partire dalle “infernali elezioni” del maggio 1921 – come le chiamerà Pietro Nenni – che lo portano alla Camera, con altri 34 fascisti. Disinvolto nel cambiare lo schema concettuale ogni volta che la convenienza delle circostanze lo richiede (“io sono un camminatore”), prontissimo a cogliere il sentire collettivo del momento, affida la politica all’azione trasformandola in rappresentazione, sapendo che la teoria seguirà, spiegando le cose a posteriori. Prima presenta il Popolo d’Italia come un foglio di sinistra, battezzandolo “quotidiano socialista”, poi nel 1918 lo corregge a destra facendolo diventare “l’organo dei combattenti e dei produttori”.
Benito Mussolini (29 luglio 1883-28 aprile 1945) in un ritratto del 1922
L’Italia della produzione è l’immagine che anticipa le corporazioni, vuole superare i contrasti di classe per fondere gli interessi di parte nel supremo interesse della Nazione, nuovo mito dominante, custode e garante di un destino imperiale promesso dai millenni. In realtà il fascismo trova nella pianura padana un interesse economico che chiede rappresentanza, una classe sociale in cerca di forza, e si mette al servizio: sono gli agrari, un capitalismo individualista e borghese cresciuto in provincia, confinato nel mondo chiuso del latifondo, costretto a fare i conti con le Leghe e le Camere del lavoro, spaventato dagli agitatori anarchici o socialisti che la sera sciolgono il mantello nelle aie e raccontano le avventure della Comune nelle stalle, o ingigantiscono l’ombra di Errico Malatesta davanti alle lampade a olio nelle veglie delle cascine, predicando che “l’interesse è sempre conservatore, solo l’ideale è rivoluzionario”.
Gli agrari sono contro i socialisti perché temono la minaccia esportabile della rivoluzione bolscevica, con Lenin che scrive a Serrati complimentandosi “per il meraviglioso lavoro del partito che riuscirà a conquistare alla causa del comunismo tutti i proletari, e allora la vittoria sarà conclusiva”, mentre Zinoviev assicura che “l’Italia presenta oggi tutte le condizioni essenziali per garantire la vittoria della rivoluzione”, e Bucharin profetizza che “la disciplina di ferro del proletariato condurrà la classe operaia italiana all’assalto delle fortezze del capitale”.
Ma quando quella minaccia declina e lo spettro di Lenin si allontana, il mondo agrario non si ferma, anzi insiste e va oltre, passa all’attacco dei diritti conquistati dai braccianti negli anni, chiede una rivincita che è una resa dei conti definitiva per il potere nelle campagne, ed è pronto a finanziarla: l’istinto di classe vuole fare piazza pulita. Il fascismo si presenta puntuale all’appuntamento con questi interessi impauriti e vendicativi, diventa il loro braccio armato, la loro massa d’urto, lo strumento della rivolta dei ceti dominanti che scende per strada. Il suo antisocialismo politico si sposa con l’antisocialismo economico, di classe, dando corpo alla reazione. Mussolini lo promette, il 6 novembre del 1920: “Noi non daremo un solo minuto di tregua al partito socialista, sino a quando non la smetterà di parlare di comunismo, di dittatura, di Russia. Come si può disarmare dalla lotta contro un partito di vigliacchi e di mistificatori che, dopo tutto quel po’ po’ di roba riferita dai missionari italiani reduci dalla Russia, ha ancora la faccia tosta di invitare le masse a inneggiare al bolscevismo nella ricorrenza dell’anniversario del colpo di Stato di Lenin?
Complessivamente sono state giustiziate a Mosca in un mese 1182 persone. E noi non dovremmo combattere – sino all’ultimo sangue – contro l’abietto partito che si propone di mascherare l’Italia alla moda di Lenin? Contro un partito che predica e pratica, quando può, l’insurrezione, i mezzi blandi non contano: ci vogliono i nostri. È una dura, spietata, implacabile battaglia, quella che abbiamo impegnato, buttando tutto nella posta in giuoco”.
L’arma è la violenza. Tutto il furore della guerra, la confidenza con la morte, l’energia distruttrice del conflitto, il sangue sulle baionette e nelle trincee, tutta la ferocia dell’epoca, l’incognita dell’avventura e l’aggressività dell’incompiuta sembrano precipitare in un risentimento collettivo che chiede di manifestarsi per farsi valere, facendo saltare i vecchi confini dentro i quali si svolgeva prima la vita civile del Paese. Il fascismo pare nato apposta per raccogliere quel rancore e trasformarlo in pura azione, gesto, moto, comunque facinoroso. Oltre il perimetro della convivenza e della regola democratica c’è la sovversione, forse la rivoluzione.
Ma prima ancora c’è il ribellismo dei ceti medi che nel disordine di una società in tumulto si sentono misconosciuti proprio mentre vogliono partecipare al riequilibrio delle categorie e degli interessi, c’è il credito accumulato e inevaso degli ex combattenti che si scoprono senza peso e senza ruolo, tagliati fuori, c’è la piccola borghesia sensitiva delle città, che avverte l’instabilità del momento e vuole inclinarla a suo vantaggio. Il fascismo è il promotore e il collettore di tutto questo, oltre che il primo attore: offre una cornice politica alla rabbia, amalgama interessi in contrasto nella semplificazione del nemico comune, traduce fisicamente ogni confronto trasformandolo in conflitto permanente.
Generato dalla febbre italiana dopo l’infezione bellica, cresciuto come rimedio e malattia, adesso è al crocevia tra le frustrazioni e le aspirazioni del Paese, tra il prima e il dopo, tra la continuità e l’inedito: che spalancherà l’abisso. Dato per morto nel 1919, in soli dodici mesi tra il dicembre 1920 e la fine del ’21 il movimento vede moltiplicarsi per dieci il numero dei Fasci presenti nel Paese, e per dodici il numero degli iscritti, fino a quota 250 mila. E come se fosse la vela più adatta alla stagione, si gonfia ogni giorno di più col vento nero del dopoguerra.
La violenza apre la strada. In un Paese sovreccitato, sottoposto a una quotidiana sollecitazione feroce, con i morti per le bombe anarchiche al teatro Diana di Milano, durante l’operetta, gli spari a palazzo D’Accursio a Bologna, l’incendio fascista dell’Avanti! a Milano, il fuoco che distrugge a Trieste il Narodni Dom sloveno, l’assalto alla Camera del lavoro a Torino, il fascismo rurale si trasforma nella milizia della reazione. Soltanto in due mesi del 1921 i morti saranno più di cento e i feriti quattrocento, con 59 Case del popolo saccheggiate, 119 Camere del lavoro devastate, 197 cooperative distrutte, 83 Leghe contadine assaltate, 141 sezioni socialiste bruciate, 100 circoli culturali smantellati: in quattro anni, prima di arrivare al potere, il fascismo fa tremila vittime.
La marcia su Roma: le camicie nere sfilano in via del Tritone
È lo squadrismo che arruola una massa indistinta, selezionata solo dal libero uso della forza e dalla trasgressione violenta, e la trasforma immediatamente in strumento militare fuorilegge, naturalmente ribelle, immediatamente eversivo. Reduci, ex legionari fiumani convinti che prima o poi D’Annunzio calerà a prendere la guida del movimento “con intera purità di cuore e di atti, servitore di una Patria che non può perire”, studenti scampati alle trincee che sperimentano la loro guerra domestica nelle piazze e nelle campagne, futuristi che seguono Filippo Tommaso Marinetti nella promessa purificatrice della “violenza travolgente e incendiaria per liberare questo Paese dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologi, di ciceroni e d’antiquari”.
Spuntano i pugnali, “per colpire coloro che assassinano la nazione”, le rivoltelle (Farinacci ne porta una sempre in tasca, e un’altra legata al polpaccio destro), i teschi, “per ricordare che la vita è un mezzo e non un fine e che di essa bisogna saper far gettito nelle ore supreme”, il manganello, arma talmente elementare da diventare feticcio simbolico. Mussolini capirà più tardi che questa liturgia squadrista celebrava sempre più la violenza fine a se stessa, in un culto senza fede e una pratica senza politica, e proverà a riprendere il controllo, faticosamente. Ma prima è lui il teorico della forza cieca, il predicatore del sopruso e della sopraffazione. Comincia corteggiando la violenza con gli slogan: “Solo osando i fascisti avranno diritto alla storia di domani”. “Noi non vogliamo più dare la nostra giovinezza a favore dei paralitici e degli impotenti”. “È la forza che all’ultimo decide”. Poi avanza una teoria generale della violenza: “Per quanto la si possa deplorare, è evidente che noi per imporre le nostre idee ai cervelli dobbiamo a suon di randellate toccare i crani refrattari. Noi non facciamo della violenza una scuola, un sistema o peggio ancora un’estetica. Quando la si impiega dev’essere generosa, cavalleresca e chirurgica. Non la piccola violenza individuale, sporadica, spesso inutile, ma la grande, la bella, la inesorabile violenza delle ore decisive”.
Quella forza prenderà la mano al fascismo, col rischio di fargli perdere il consenso della borghesia, finalmente spaventata dal clima di guerra civile costante. Mussolini, avvertendo “un cerchio d’odio intorno al fascismo che ha eretto le sue fortune sui catafalchi”, propone una via d’uscita per non trasformare le piazze d’Italia “in pubblici scannatoi”: è il patto di pacificazione, un accordo di tregua coi socialisti, che verrà firmato solennemente e subito abbandonato e disatteso. Si ribella infatti l’anima di ferro del partito, con Grandi, Marsich e Farinacci, come se lo squadrismo fosse diventato una forza a sé stante, autonoma e autoalimentata dalla stessa brutalità abusiva che produce, capace di dettar legge al fascismo che lo ha generato.
Il Duce, come lo aveva battezzato anni prima il vecchio socialista emiliano Olindo Vernocchi, rischia di perdere il partito. “Io sono Duce per modo di dire. Non ho mai imposto nulla a chicchessia. Volete dare un addio al fascismo italiano? La cosa mi lascia indifferente, o quasi. Per me il fascismo non è un fine, ma un mezzo. Può fare a meno di me? Certo, ma anch’io posso fare a meno del fascismo: c’è posto per tutti in Italia”. Si dimette dalla commissione esecutiva, per esasperare il conflitto e forzare la mano. Ma è troppo tardi. Lo squadrismo domina il campo, e per riprendere il controllo del movimento Mussolini deve trasformarlo in partito, in modo che la guida politica prevalga ovunque sulla forza militare.
E quando il governo Bonomi impartisce a prefetti e questori l’ordine di “disarmo dei cittadini”, invitandoli a sciogliere i gruppi armati, il Fascio reagisce stabilendo che a partire dal 15 dicembre 1921 partito e squadre di combattimento diventino una cosa sola, perché tutti gli iscritti al movimento da quel momento faranno automaticamente parte dell’organizzazione squadristica. A questo punto per sciogliere la componente militare del fascismo bisognerebbe sciogliere il partito, mettendolo fuorilegge. Lo squadrismo alzando la posta ha vinto la partita, si prepara al passo finale.
Durante la marcia su Roma reparti fascisti avanzano per le vie della città bruciando i ritratti di Lenin
Mussolini capisce che non può fare a meno di quel fascismo di strada e di manganello che ha scatenato e che ormai fa fatica a manovrare a comando, quando deve passare per ragioni tattiche dal pugno di ferro alla diplomazia parlamentare. Lui stesso è diviso tra le due anime. Odiava la barba, tipica dei socialisti, ma diceva di non aver tempo per radersi, si infilava i giornali e i libri nelle tasche gonfie delle giacche, portava scarpe consumate e spesso impolverate per la fretta, d’inverno teneva il bavero del pastrano continuamente sollevato, come farà nei suoi ultimi giorni.
Adesso entra in parlamento perfettamente sbarbato, con il cappello nella mano sinistra, veste con cura il soprabito scuro, la camicia bianca col colletto duro e le punte rovesciate irrigidite dall’amido, indossa il tight e la marsina nelle cerimonie ufficiali, va a cavallo con gli stivali e gli occhiali scuri, sale in treno con la pochette a due punte nel taschino e la giacca abbottonata, quando deve ricorrere alla camicia nera la accompagna con una cravatta scura. Ma continua a prender lezioni di scherma per allenarsi ai duelli proibiti con la spada: e nel suo ufficio di direttore del Popolo d’Italia insieme con due rivoltelle, un pugnale, il teschio disegnato sulla bandiera nera degli Arditi, ci sono le bombe a mano allineate dietro il vetro smerigliato della libreria, nascoste dentro la vecchia stufa, appoggiate sulla scrivania, in modo che possa accarezzarle con la mano mentre beve il latte caldo inzuppato coi biscotti, due per volta.
La violenza non era solo nelle piazze, ma nell’aria. L’illusione dannunziana mitologica del Carnaro faticava a spegnersi, anche dopo la fine della reggenza del Vate, con l’esercito italiano che circonda Fiume e sgombera i legionari che l’avevano occupata. Da tre anni, come una polvere sottile, le voci di un colpo di Stato riempiono i corridoi dei palazzi romani, i dispacci degli ambasciatori, i sospetti dei giornali, i pettegolezzi dei partiti. Si inseguono le ipotesi, dal governo militare a un putch dinastico, col duca d’Aosta pronto a prendere il posto di re Vittorio Emanuele III, a una dittatura di destra, che sbarri definitivamente la strada ai socialisti e ai comunisti, mettendoli fuori legge. “Io non mi sono mai lasciato convincere da queste sirene – spiega Mussolini – anche se venivano da generali a spasso che credono di avere la ricetta con cui si salva il mondo, perché quella della dittatura è una carta grossa, che impone rischi terribili e giocata una volta non si gioca più”.
Ma proprio dal Capo del fascismo, intanto, viene una continua denigrazione dello Stato, e una costante umiliazione della democrazia. “Lo Stato? È un corteo di sessanta, settanta tube, solenni, disordinate, malinconiche, che si riuniscono nelle grandi occasioni. E la Camera è vecchia, fradicia e imputridita con uomini usati e abusati, stanchi e, peggio ancora, stracchi. La democrazia agonizza in tutti i Paesi del mondo. Può darsi che nel secolo scorso il capitalismo avesse bisogno della democrazia, oggi può farne a meno. La guerra ha liquidato tra fiumi di sangue il secolo democratico del numero, della maggioranza e della quantità: gli succede un secolo aristocratico. Lo Stato di tutti finirà per tornare lo Stato di pochi. Pochi, ed eletti”.
E infatti lo Stato liberale tramonta, divorando quattro governi dal 23 marzo 1919, quando è nato il fascismo, al gennaio 1922, con l’uscita di scena di Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, Giovanni Giolitti e Ivanoe Bonomi. L’autorità statale si sta disgregando perché ha perso la leva di comando delle forze dell’ordine, nella connivenza delle polizie con le bande armate che saccheggiano le sezioni socialiste e incendiano le Camere del lavoro, mentre i questori restano passivi: o magari, come il prefetto di Alessandria soverchiato dalle spedizioni squadriste, accendono candele al loro santo protettore.
Ma la legalità politico-amministrativa viene minata nella sua base popolare diffusa, cioè nei municipi, che i fascisti occupano per rovesciare le giunte rosse, penetrando di notte nelle case dei sindaci e degli assessori e obbligandoli a firmare le dimissioni, minacciando con le armi mogli e figli. Nel 1920 l’ordinamento civico del Paese è rovesciato, con un’operazione violenta che svelle la democrazia rappresentativa nelle città, cancellando le scelte dei cittadini: 289 comuni vengono sciolti, come altri 365 nel 1921. Ancora la notte prima di Natale quindici uomini tentano di entrare nella casa di Giulio Simonetti, sindaco socialista di Pozzonovo, spacciandosi per agenti di polizia, e quando la porta resta chiusa sparano con le pistole contro le finestre illuminate, da dove qualcuno risponde con un colpo di fucile che uccide il capo del gruppo d’assalto, Luigi Tinassi di 23 anni.
È la sovversione che assedia lo Stato dal basso. Pochi giorni prima, parlando alla Camera, Mussolini prova a minimizzare: “Non bisogna esagerare la gravità della situazione di piazza, perché i veri punti neri sono altri, il deficit finanziario, la disoccupazione e il caro-viveri. E lo sbandamento morale del proletariato non è dovuto all’azione più o meno violenta del fascismo, ma al crollo di tutte le ideologie che avevano alimentato gli entusiasmi del dopoguerra”. Cauto perché inquieto, il Duce teme soprattutto che il clima di guerra civile scatenato dagli squadristi inneschi una contro-reazione a sorpresa, convincendo infine i socialisti a accettare un’alleanza con i democratici e i popolari per un governo Giolitti pronto a domare la violenza fascista. Da un lato Mussolini cavalca le incursioni feroci e illegali dei suoi uomini, dall’altro si muove con prudenza in parlamento, coltivando due tattiche diverse, nell’incertezza di decifrare un Paese che ribolle: con il re imperturbabile mentre alle 10,30 di domenica primo gennaio riceve con la sovrana i cinque Collari dell’Annunziata Bonomi, Boselli, Salandra, Sforza e Thaon di Revel che gli presentano gli auguri, chinando il capo: come se dal Quirinale si affacciassero su un Paese normale.
Certo in quel giorno il Duce non poteva sapere che il 1922 sarebbe stato l’anno in cui si impadroniva dell’Italia. Ma scrutava i segni fin da bambino, diffidente dei raggi di luna malefici e delle mummie egiziane, attento ai presagi del primo giorno dell’anno e ansioso di prevedere l’imponderabile nei sogni, nelle carte, nei ritratti incollati, guardingo con le influenze dell’aldilà che aveva imparato a rispettare dalla vecchia Giovanna dai tre mariti, vicina di casa con fama di fattucchiera. Le prove che si annunciava un anno eccezionale, torbido e misterioso, in quel gennaio si affollavano: il metro di neve caduto a Palermo, gli orologi da tasca che si fermano improvvisamente senza una causa apparente come se si rifiutassero di far scorrere le ore, l’anarchico Antonio D’Alba, da poco rimesso in libertà dopo l’attentato al re, sorpreso in ginocchio a brucare l’erba di un prato, le rivelazioni del professor Fisher sui chimici tedeschi che sarebbero riusciti a produrre l’oro sintetico, un giovane bloccato in Vaticano dai gendarmi svizzeri che insiste per consegnare di persona al pontefice un annuncio divino segreto, ottenuto durante una visione direttamente dal Padreterno.
Nessuno lo sa, ma in quelle stanze e in quei giorni il Papa sta morendo. Il mondo avrà la notizia poco prima dell’agonia, quando l’infiammazione dai bronchi passa al polmone destro mentre il cuore è sempre più depresso, l’archiatra Battistini convoca un consulto e Benedetto XV chiede la comunione. Morirà il 22 gennaio, con L’Ordine Nuovo di Gramsci che bolla un pontificato “di ordinaria amministrazione, prefigurato da un’elezione di compromesso”, l’Avanti! che saluta “un Papa sbagliato” e Mussolini che approfitta per riposizionarsi prendendo le distanze dal laicismo e dal vecchio anticlericalismo: “stanno agonizzando, mentre le masse anonime popolari sono tormentate dal desiderio di rifugiarsi nell’assoluto della fede e i sentimenti religiosi stanno potentemente tornando nell’animo umano”.
Quel sentimento scoprirà il mistero della profanazione proprio nel cuore sacro di Milano, la basilica di Sant’Ambrogio, dove una notte prima dell’Epifania qualcuno incredibilmente penetra nella cripta dov’è custodita l’urna d’argento e cristallo che ospita dal 1874 sotto l’altare d’oro i corpi dei santi Protasio e Gervasio e del vescovo patrono di Milano, venerato da più di quindici secoli. Un anello e un grande fermaglio di brillanti strappati al santo non spiegano il sacrilegio che infrange un divieto di apertura del sepolcro pronunciato addirittura dallo stesso Ambrogio, “pena gravi punizioni divine”.
Un sacro interdetto pende dunque sul 1922, a partire proprio da gennaio, cent’anni fa, ma non sembra preoccupare i fascisti. “Mi chiedo che cosa ci porterà l’anno nuovo – scrive infatti nel suo diario Italo Balbo, il gerarca amico fraterno di Mussolini – . Siamo padroni della situazione. Non solo abbiamo fiaccato la resistenza degli avversari, ma gli organi pubblici sono sotto il nostro controllo”. Il Duce vede tutto questo, e tuttavia è indeciso, dominato dalla volontà di potenza ma turbato nello stesso tempo dalla paura di perdere tutto: “Il fascismo può aprire la porta con la chiave della legalità, ma può anche essere costretto a sfondarla con la spallata dell’insurrezione”. I segni del futuro sono incerti, giù in fondo è buio, come quando il ragazzo Benito si svegliava di notte con la sua civetta viva sul trespolo accanto al letto, “e vedevo quegli occhi tondi, gialli come dischi d’oro, fosforescenti e spalancati a vegliarmi”.
(1. continua)