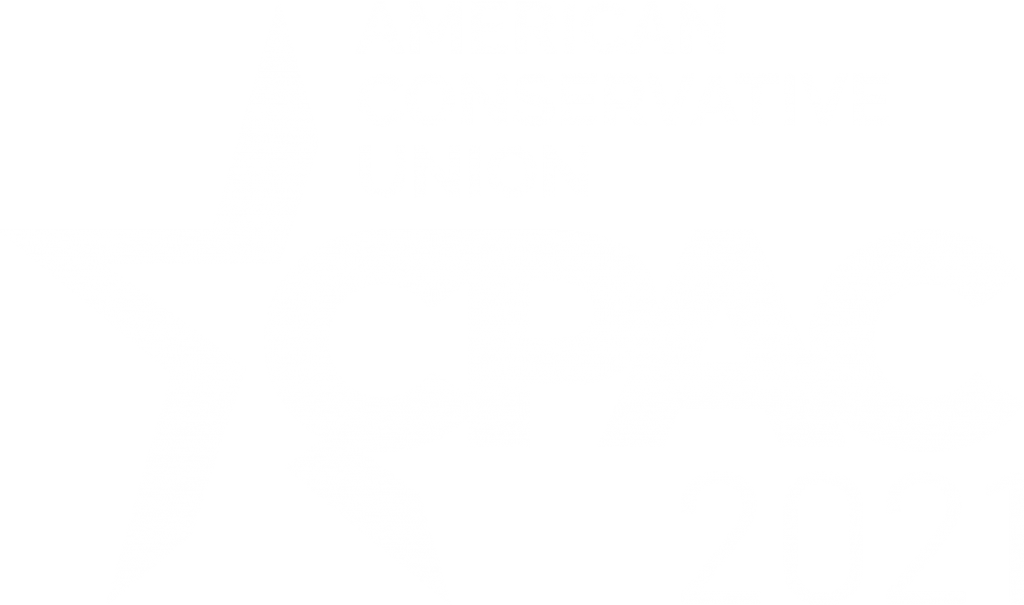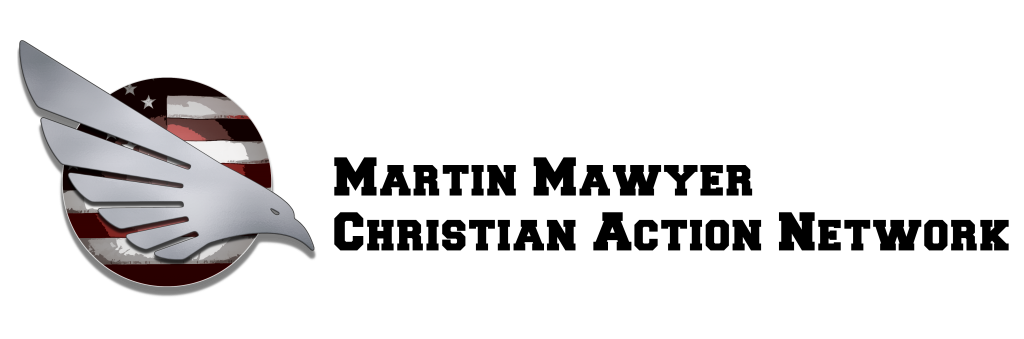Alla fine l’ha scoperto anche Giorgia Meloni. Ed è stato un risveglio amarissimo. A non volerla premier non sono solo la detestata stampa statunitense filodemocratica e almeno una buona metà degli italiani, ma anche i suoi alleati. Soprattutto i suoi alleati, verrebbe da dire. E senza di loro – per usare la metafora del forzista Antonio Tajani – potranno pure vincere la partita (elettorale), ma alla fine potrebbe non essere lei ad alzare la coppa.
Insomma, da quella parte della barricata la lite su un post vittoria ancora tutto da conquistare è già iniziata. L’impressione abbastanza lampante, alla vigilia dello start della campagna elettorale, è che la leader di FdI, aspirante primo presidente del Consiglio donna, più che da una fantomatica “macchina del fango” dovrebbe guardarsi le spalle dal fuoco amico. Quello intenzionato a sbarrarle la strada d’accesso a Palazzo Chigi. Magari proprio perché donna, chissà.
Quel che è altrettanto evidente è che i tre moschettieri della destra sovran-populista hanno stretto un patto scellerato. L’obiettivo è portare il Paese il più lontano possibile dall’Europa della Next generation Eu e del modello Ursula, per avvicinarlo sciaguratamente al dogma dell'”amico” Viktor Orbán, quello del proclama nazista di ieri, degli ungheresi che “non vogliono mescolarsi con altre razze”.
Il fondamento di quel patto invece è una spartizione di potere e poltrone. La Le Pen italiana alla guida di un ipotetico governo che fa già tremare le cancellerie internazionali. Il Cavaliere alla presidenza del Senato che gli acconcerebbe su misura la seconda carica dello Stato, dato che condanne e buon senso (degli altri) gli hanno precluso per sempre la prima. Il Capitan spranga-porti di ritorno al Viminale: ripiego minimalista per un segretario mai diventato grande e che ha dovuto archiviare – anche lui pare per sempre – ogni velleità di premiership. Tanto che, per un paradosso figlio degli equilibri sovvertiti, ora è proprio Matteo Salvini a difendere la regola del premierato da assegnare al capo del partito più votato, in una sorta di sottomissione preventiva alla nuova leader (la Lega ormai stabilmente sotto il 20 per cento), nella speranza che il vassallaggio possa restituirgli la stelletta da piccolo sceriffo dei mari e dei confini.
Poltrone insomma, potere nella sua accezione più utilitaristica. Quel che in fondo ha sempre tenuto insieme la destra italiana. Post fascista, berlusconiana o sovranista, poco cambia. La realtà, ad appena 61 giorni dal voto, è che quei tre non si fidano l’uno dell’altro, temono agguati, vedono insidie, sospettano tradimenti. Non esattamente il miglior viatico per chi sente di avere già la maggioranza degli italiani dalla sua e si proietta con la fantasia sul balcone di Palazzo Chigi.
Ora, se una lezione tutto questo può insegnare a chi si muove da quest’altra parte della barricata, da Enrico Letta a Carlo Calenda, da Matteo Renzi a Roberto Speranza a Luigi Di Maio e forse perfino a Giuseppe Conte, è che la partita non è ancora finita. Che i retropassaggi avventati e spregiudicati degli avversari forse potrebbero favorire i virtuali perdenti.
Certo, per vincere bisognerebbe essere una squadra. Una squadra è fatta da giocatori. E un giocatore lo vedi non dagli occhi della tigre, ma “dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”, insegna il maestro De Gregori.
Peccato che qui si stia ancora ragionando su quale sia il campo da utilizzare. Il tutto sotto gli occhi attoniti degli italiani, che cercano di capire perché sia stato defenestrato anzitempo il premier più accreditato che il Paese abbia avuto negli ultimi decenni, perché dovranno sorbirsi una campagna elettorale da bollino rosso e, soprattutto, perché dovrebbero tornare ad aver fiducia nella politica.
Se ne esiste ancora una del buon senso e del buon governo è questo il momento di dimostrarlo. Il tempo per farlo è già quasi scaduto.