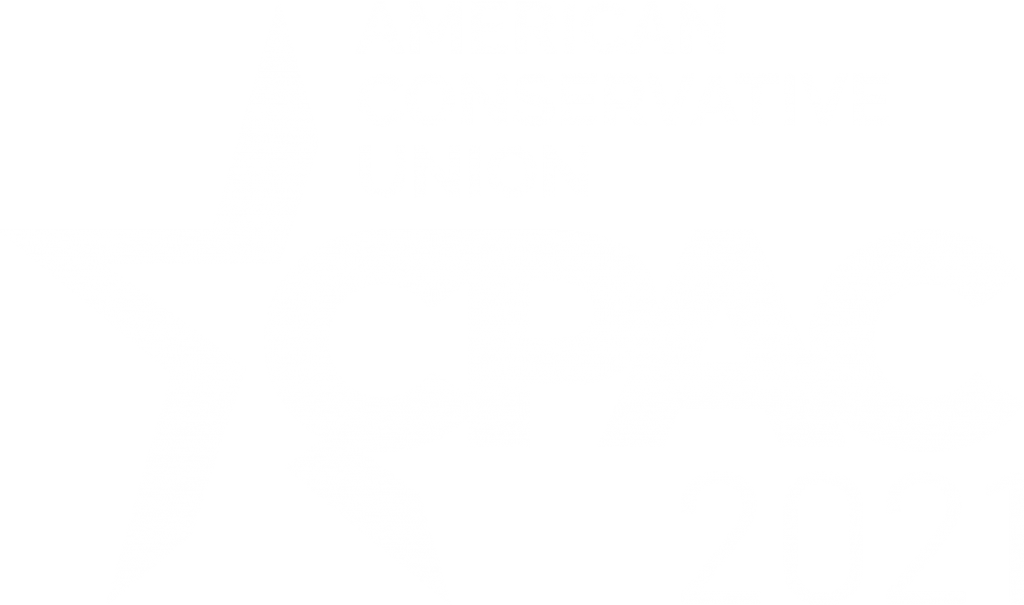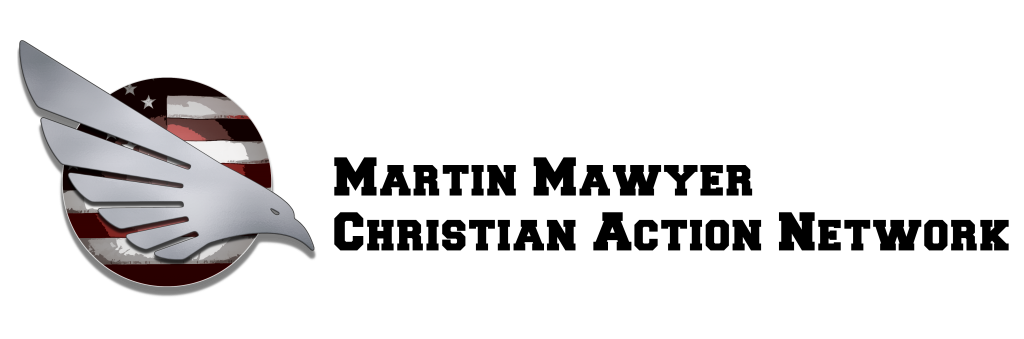Quando l’hanno battuta le agenzie, poco prima di Natale, la notizia ha faticato a conquistarsi una breve. Due chiusure indagini per la strage di piazza della Loggia e due nuovi e semisconosciuti estremisti di destra accusati di aver messo la bomba che dilaniò Brescia alla fine del maggio di 48 anni fa, uccise otto persone, ne ferì un centinaio, inaugurò l’ennesima stagione dello stragismo di mano neonazista con la complicità di pezzi dello Stato. Già perché ha già due colpevoli, quell’attentato, arrivati però soltanto con la sentenza di Cassazione del 2017. Uno, Carlo Maria Maggi, ex capo dell’organizzazione neofascista “Ordine Nuovo” nel Triveneto, è morto l’anno dopo. L’altro, Maurizio Tramonte, la fonte “Tritone” del Sid (l’allora servizio segreto militare), sta ancora combattendo la sua battaglia per la revisione del processo. Per questo, le storie di Marco Toffaloni e Roberto Zorzi – che sono appunto i due accusati dell’ennesima indagine della Procura di Brescia – potrebbero benissimo essere due note a margine della storia nera d’Italia. Invece, nelle 280mila pagine (mal contate) di atti depositati in Tribunale, e consultati integralmente da Repubblica, c’è molto altro. C’è la consueta ricerca documentale del “secondo livello” (quello degli uomini incardinati nelle istituzioni italiane) e ci sono nomi e cognomi di ufficiali degli apparati: Sid, Carabinieri, Polizia. Ma c’è, soprattutto, l’indicazione di un inedito terzo livello. Parliamo del Comando Forze Terrestri Alleate per il Sud Europa – leggi: Nato – il cui cuore sarebbe stato a Palazzo Carli, a Verona, la città di Toffaloni e Zorzi. Qui, con la copertura di generali dei paracadutisti italiani e statunitensi, si sarebbero svolte le riunioni preparatorie di un progetto stragista che avrebbe dovuto sovvertire la democrazia italiana e rinsaldare lo scricchiolante fronte dei regimi del Mediterraneo. Quello che, all’epoca, teneva insieme il Portogallo salazarista, la Grecia dei colonnelli e la Spagna franchista.
D’istinto, lo si direbbe un romanzo fantasy costruito su migliaia di informative, verbali, intercettazioni, pedinamenti e vecchi faldoni, recuperati dalla magistratura negli archivi dei nostri Servizi e in quelli degli Stati Maggiori dei nostri apparati militari e della sicurezza a forza di decreti di esibizione, e in cui si dipana anche la storia di un pugno di ragazzi figli di quel tempo. Con la passione per il calcio, le moto, i giochi da adulti, l’esoterismo. Un mondo popolato da donne bellissime e attori, svastiche e orge, agenti doppi e vendette. Per una vicenda tragica che ha fatto morti prima di quel terribile 28 maggio 1974, e forse continua a farne. Già, perché chi indaga sulla strage di Brescia si è sempre trovato di fronte a due nodi da sciogliere. A due bombe. La prima, esplosa nove giorni prima, alle 3 di notte, falciò un ragazzo di vent’anni in Vespa. Si chiamava Silvio Ferrari, era un neofascista che aveva già commesso attentati e andava a far saltare l’uscio della sede della Cisl. Ma non fece in tempo. Saltò in aria all’imbocco di piazza Mercato. Fatalità, errore umano o trappola? Uno dei migliori amici di Ferrari, Arturo Gussago, finì a processo accusato di strage, e come tutti i coimputati fu assolto. Faceva l’avvocato. Il 24 dicembre, quattro giorni dopo la chiusura di questa inchiesta, un infarto lo ha stroncato. Il supertestimone che ha guidato gli investigatori tra i segreti bresciani e fino al comando Nato di Verona (lo chiameremo “Alfa”, per motivi di sicurezza, e sarà l’unico nome che non faremo), ha fatto tanti nomi di persone coinvolte nella strage. Quello di Gussago è stato l’ultimo, pochi mesi fa.L’avviso di conclusione delle indagini preliminari per Marco Toffaloni. Brescia, 20 dicembre 2021
Déjà vu
Questa storia comincia, o meglio, ricomincia, quando ancora l’ultimo dibattimento è alla prima delle sue cinque puntate. Alla sbarra, oltre a Maggi e Tramonte, ci sono il neofascista Delfo Zorzi (uscito indenne dai processi per piazza Fontana e la strage di via Fatebenefratelli del 1973), Pino Rauti in quanto nume di Ordine Nuovo, il chiacchieratissimo generale dei carabinieri Francesco Delfino, che a Brescia condusse le prime inconcludenti indagini, e il suo confidente Gianni Maifredi. Camicie nere, pezzi di Stato, mondo di mezzo tra neofascismo e criminalità. Giampaolo Stimamiglio è tra le gole profonde di quell’inchiesta e tra i testimoni-chiave dell’accusa. Padovano, molto amico di Giovanni Ventura, ex Ordine Nuovo poi passato alla V Legione, Stimamiglio è un reduce che molto sa e molto ha sentito dire. Nel luglio del 2009, non avendo ancora vuotato il sacco dopo quindici anni di interrogatori, contatta il colonnello del Ros Massimo Giraudo, investigatore che naviga il mare dell’eversione dall’inizio dei Novanta, godendo del massimo della fiducia da alcune Procure (Brescia, Palermo) e del minimo da altre (Milano, Bologna). All’ufficiale, Stimamiglio racconta due cose. Due confidenze che avrebbe raccolto dal generale in pensione Amos Spiazzi, altra vecchissima conoscenza delle trame nere, versante golpista, fin dall’arresto per l’affaire Rosa dei Venti.
La prima: piazza della Loggia, nella sua fase operativa, sarebbe stata una joint venture tra neri bresciani e veronesi.
La seconda: c’era un ruolo atlantico nella regia della bomba, e un uomo chiave sarebbe stato Aldo Michittu. Già, proprio l’ufficiale protagonista di uno scandalo da operetta nel 1993, una storia di complotti presunti e ricatti veri ordita insieme alla moglie e starlette Donatella Di Rosa, impietosamente ribattezzata “Lady Golpe”.
Sembra una trama da serie tv, quella di Stimamiglio, che nei mesi successivi aggiunge dettagli nuovi. C’era una “Scuola”, tra i duri e puri di Ordine Nuovo a Verona, che addestrava i suoi adepti agli attentati. Evoca Elio Massagrande e Roberto Besutti, due nomi storici del neonazismo più radicale, e i loro allievi Paolo Marchetti, Fabrizio Sterbeni, Roberto Zorzi, Umberto Zamboni, Marco Toffaloni. Ognuno di loro, negli infernali Settanta, aveva almeno un fascicolo a carico. Dice, infine, il confidente, che ad ammazzare Silvio Ferrari non fu il fato, ma una mano omicida che aveva manipolato il tritolo, ed era scaligera. Stimamiglio vorrebbe il programma di protezione. Nell’attesa, accetta di mettere tutto nero su bianco con i magistrati. La voce corre anche tra i vecchi camerati e qualcuno di loro, come Stefano Romanelli, comincia a parlare tra mille reticenze. Finché, il 6 aprile 2011, Giampaolo Stimamiglio cala l’asso. Rivela di aver incontrato, vent’anni prima, Marco Toffaloni. Erano nel motel gestito a quel tempo da Claudio Bizzarri, altro chiacchieratissimo ex camerata, parà già inquisito da Vittorio Occorsio e di recente accostato alla strage di piazza Fontana. Sorrideva, quel giorno, Toffaloni, rivangando i bei tempi. E a un tratto esclama: “Anche a Brescia gh’ero mi!”. Piazza della Loggia? “Son sta mi!”. Eppure, il 28 maggio 1974, Marco Toffaloni si avvicinava al suo diciassettesimo compleanno. Stimamiglio chiese: c’era anche Roberto, te l’ha consegnata lui? “Sì, certo”. I pm Piantoni e Chiappani e il procuratore Pace sobbalzano. L’11 aprile Marco Toffaloni e Roberto Besutti vengono iscritti nel registro degli indagati. Di Michittu non si sentirà più parlare.
28 maggio 1974
Tomaten
Il vecchio e il giovanissimo. Un istruttore di lanci d’aereo col mito della Rsi, che dalla metà degli anni Sessanta faceva la spola tra Mantova e Verona, conosciutissimo da Servizi e Antiterrorismo. E un ragazzino col mito del superuomo e dell’esoterismo, delle armi e del fuoco, che si era fatto una fama nera fin da minorenne. Prima con Amanda Marga, la setta importata dall’India che predicava purezza e svastiche. Poi con gli incendi dolosi delle Ronde Pirogene Antidemocratiche, banda che colpiva tra Bologna e Verona e vantava stretti legami – e forse qualcosa di più – con Marco Furlan e Wolfgang Abel, il duo che sotto la sigla “Ludwig” aveva sterminato decine di vittime colpendo tra gay, disabili, frequentatori di discoteche e cinema porno. Lo chiamavano “Tomaten”, Marco Toffaloni. Alla tedesca. Per quel suo vezzo di arrossire spesso. Ma era la sua unica debolezza. Feroce negli scontri di piazza, fin dai tempi in cui distribuiva il giornaletto Anno Zero fuori dai licei dei rossi, per poi pestarli insieme ai camerati. Ma vantava anche letture e frequentazioni kremmertziane, frequentazioni massoniche, amicizie (Rita Stimamiglio, Beppe Fisanotti, Paolo Marchetti) in comune con i Nar Gilberto Cavallini e Giusva Fioravanti.
Non è un’indagine semplice, quella su “Tomaten”. Intanto è diventato cittadino svizzero e ha cambiato nome in Franco Müller, prendendo il cognome dell’ex moglie Silvia. Poi sfida gli inquirenti, non si presenta agli interrogatori, fa sapere di avere coperture tra i carabinieri ed in effetti, rovistando nei suoi fascicoli, i militari del Ros trovano parecchie anomalie. Non è facile nemmeno farsi strada in quell’ambiente. Gli ordinovisti di un tempo tacciono. O sono all’estero, come Roberto Zorzi, che ha portato la famiglia a Snohomish, nei pressi di Seattle, fa il predicatore e alleva dobermann da competizione nel “Kennel del Littorio”. Nomen omen. Oppure muoiono. Scompare Stefano Romanelli, il “camerata Toba”, sul punto di diventare gola profonda. Si spegne, il 31 maggio 2012, Roberto Besutti. E l’accertamento principale, la verifica dei registri scolastici per il 28 maggio 1974, dice che Marco Toffaloni, quella mattina, era in classe. Non si sa se tutto il giorno, soltanto alla prima ora o l’ultima. Ma era al suo banco in 3ª B. Anche Spiazzi, interrogato dai magistrati, nega di aver mai confidato alcunché a Stimamiglio, gli accertamenti si disperdono in mille rivoli senza nessun vero sbocco e, alla fine del 2013, il procuratore dei minori Emma Avezzù (“Tomaten” era sedicenne, il giorno della strage) si convince a chiedere decreto d’archiviazione. Non si arrende il pm Francesco Piantoni, in Procura ordinaria, ma il suo fascicolo ora è a carico di ignoti.
28 maggio 1974, le immagini
Alfa
C’era, però, ancora un segreto da esplorare su Marco Toffaloni. Un vecchio commissario in pensione, Giordano Fainelli, racconta al colonnello Giraudo di come, all’Ufficio Politico e al Nucleo Antiterrorismo di Verona, le indagini sui neofascisti avessero parecchi buchi. Pensi, spiega l’ex poliziotto all’ufficiale dei Ros, che una volta perquisimmo la cantina di “Tomaten” e trovammo un deposito di esplosivo. Forse anche quello usato in piazza della Loggia. Ma quel materiale, e quel verbale, sparirono. Ed in effetti Giraudo e l’ispettore Michele Cacioppo, investigatore di punta della Dcpp del Viminale, non trovano nulla in nessun archivio. La ricerca diventa empirica. Anagrafica. Trovare i vicini di casa dell’epoca del ragazzo. Sollecitare la loro memoria. Finché i carabinieri non ne trovano uno che parla. Che sa, o almeno, ricorda: “Non oltre il 1978 mio padre mi disse che Marco Toffaloni era coinvolto nella strage di Piazza della Loggia, la notizia la ebbe dai genitori di Marco con i quali era in ottimi rapporti”. È un nuovo filo, da seguire. Il testimone indica due amici di “Tomaten”, due frequentatori di quella cantina. Uno, Nicola Guarino, viene convocato in caserma e colto con la guardia abbassata. Parla di una riunione dell’inizio del ’74 con Toffaloni, imberbe ma già assai critico con le nuove leve di Ordine Nuovo, troppo morbide per i suoi gusti. Per la rivoluzione, diceva, bisognava fare qualcos’altro.
Bisognerebbe, aggiunge Guarino – che dopo quel verbale farà marcia indietro e non collaborerà più – cercare gli altri partecipanti di quella riunione. E gioverebbe, aggiunge l’ex camerata Umberto Zamboni, cercare i proprietari di due vecchie auto, segnalate nelle prime indagini bresciane: una Bmw grigia e una Citroen Dyane celestina, entrambe targate VR. Ne aveva parlato, all’epoca, Ermanno Buzzi, il sedicente “conte di Blanchery”, ambiguo ladro d’arte con le SS tatuate su una mano e agganci ovunque, anche in tribunale. Il primo processo aveva puntato su di lui e la sua corte, in primo grado nel 1979 Buzzi aveva preso l’ergastolo ma non arrivò mai all’appello, strangolato in carcere da Mario Tuti e Pierluigi Concutelli. Tutte le sentenze successive oscilleranno tra il “cadavere da assolvere” e il ruolo operativo nella strage. Gli inquirenti vanno a ripescare tutti i protagonisti del procedimento originario. Si imbattono in “Alfa”, personaggio vicinissimo a Silvio Ferrari, testimone diretto della cena alla pizzeria Ariston, la sera del 18 maggio 1974, tra Silvio e il suo omonimo Nando Ferrari, neofascista veronese che lo convinse a commettere l’attentato, dopo aver festeggiato tutta la notte con amici in una villa sul lago. “Alfa” parla. E rivela uno scenario sconcertante.
I protagonisti
L’appartamentino
Spiega che Silvio Ferrari, negli ultimi mesi della sua vita, lo portava in un monolocale mansardato nel centro di Brescia, in una strada a fondo cieco. Via Aleardi. Qui, nel bagno, il ragazzo aveva una camera oscura. Sviluppava foto. E poi riceveva, alternativamente, i carabinieri in borghese mandati dall’allora capitano Delfino, comandante del Nucleo investigativo, o il vicequestore Lamanna dell’Ufficio Politico. Consegnava le buste con le foto sviluppate e intascava soldi. Tanti. E da troppe mani. Un’attività clandestina da informatore che era rimasta un segreto per quarant’anni. Del resto, di quell’appartamentino, avevano già parlato in passato il neofascista bolognese Luigi Falica e lo stesso Umberto Zamboni. Alfa dice ancora che alla famosa cena del 18 maggio, c’erano anche tre veronesi arrivati sulla celebre Dyane celestina. Che uno era un marcantonio, e la terza una ragazza. Che Silvio Ferrari, inoltre, conosceva bene Maurizio Tramonte, la fonte “Tritone”. Il materiale per far lievitare l’indagine c’è. Anche perché i carabinieri del Reparto Operativo di Verona, incaricati di analizzare le foto in bianco e nero della strage scattate in presa diretta dal reporter Silvano Cinelli, fanno una scoperta sorprendente. Tra i volti immortalati a fissare i cadaveri, ce n’è uno giovanissimo. Con una stupefacente somiglianza con un’antica segnaletica di Marco Toffaloni. Il consulente antropometrico Tommaso Capasso conferma. Ma, nel frattempo, le rivelazioni di “Alfa” proseguono. Dice che, tra le foto messe in busta nel monolocale, ce n’erano alcuni di paracadutisti in esercitazione a Pian del Voglio. E una sequenza che riprendeva il capitano Delfino in persona e, di spalle, Nando Ferrari. Che quegli scatti, sviluppati da Silvio, provenivano dall’interno di una caserma e li aveva richiesti lo stesso Delfino, frequentatore dell’appartamentino.
“Alfa” ha paura delle conseguenze di queste rivelazioni, spiega di essere stato già minacciato di morte in passato perché quel segreto doveva rimanere tale. Ma non smette di parlare, e il colonnello Giraudo di annotare: “Era ben chiaro che Delfino intendeva che aveva fatto ammazzare Silvio Ferrari, ma egli lo diceva anche come se sapesse perfettamente che io sapevo che era andata così”. L’accusa al generale, nel frattempo assolto in Tribunale e scomparso, è terribile. “Alfa” non risparmia nemmeno il fu Silvio Ferrari:
Ci credeva veramente e faceva la spia, ma ricattava anche i Carabinieri, era molto, molto attaccato ai soldi
Il romanzo si arricchisce di paragrafi inquietanti. “Tomaten”, dalla Svizzera, percepisce vibrazioni sfavorevoli. In una conversazione (intercettata) con le sorelle appena interrogate, le mette in guardia: “Dovete andare assolutamente da un avvocato per non farmi dei danni – incalza – perché mi state facendo dei danni assurdi, inconsapevolmente. Loro hanno degli intrighi”. Ma non è l’unico nel mirino, l’uomo che si faceva chiamare “Acastasi” ai tempi delle Ronde Pirogene. Il 4 febbraio 2015 Umberto Zamboni fa un’altra rivelazione dirompente: “Mi sento oggi di dire che all’epoca, a me, così come ad altri di Ordine Nuovo, era noto che la strage di Piazza della Loggia aveva visto la partecipazione di veronesi. Posso specificare più di uno. Mi sento ancora di aggiungere che uno dei nomi che mi venne fatto quale veronese coinvolto nella strage di Brescia è Roberto Zorzi”.
Il marcantonio
Figlio di un marmista, corpaccione robusto (Alfa lo riconoscerà come il marcantonio della famosa cena), capelli biondi corti e baffetti alla Hitler, Zorzi aveva vent’anni all’epoca della strage. Era tra gli ordinovisti più duri all’ombra dell’Arena e del Bentegodi, frequentandone già allora la curva con i suoi camerati. Durante la campagna per il referendum sul divorzio affiggeva i manifesti dei Guerriglieri di Cristo Re, sigla oltranzista di importazione franchista. Lo chiamavano il “pirata”, spavaldo com’era, ma anche “la fleur”, perché aveva lavorato presso un fiorista. E di fiori, il ragazzo, si era occupato anche il giorno dei funerali di Silvio Ferrari: un cuscino, con l’ascia bipenne e il nastro in raso firmato “I camerati di Anno Zero”, che la delegazione veronese aveva portato a Brescia il 21 maggio 1974. Erano in tanti, quel giorno, a braccio teso al cimitero a fare il presente. Messaggi minatori, che gridavano vendetta per il giovane saltato in aria sulla Vespa, cominciavano già a circolare.
A sinistra la vespa di Silvio Ferrari. A destra la corona di fiori al funerale, con il simbolo di Ordine Nuovo Quel pomeriggio, con piazza del Mercato presidiata dagli extraparlamentari di sinistra, i neofascisti andarono a cercare, e trovare lo scontro. Cinque di loro, tutti veronesi, vennero arrestati perché trovati in possesso di una pistola e una piccozza: Nicola Guarino, Alberto Romanelli (cugino di “Toba”), Arianno Avogaro, Nico De Filippi Venezia e Franco Francescon. Zorzi no, era riuscito a svignarsela in tempo sulla Seicento di Umberto Zamboni, all’epoca in carcere. Ma la sua targa era stata annotata. E il capitano Delfino, il pomeriggio stesso della strage, aveva diramato un telex urgente ai carabinieri di Verona, che avevano rintracciato Zorzi a casa della fidanzata e lo avevano portato via con una coperta sui polsi, a coprire le manette. Fermato per strage, in caserma, mentre i sottufficiali inviati da Brescia ne controllavano l’alibi. Disse, “il pirata”, di aver passato la mattinata a Porta San Giorgio, al bar di fronte alla fermata delle filovie. Lì a bighellonare e chiacchierare, dalle 8 alle 11. E poi, nel pomeriggio, insieme a “Toba” Romanelli. Gli accertamenti si erano limitati a un controllo al bar. E il capitano Delfino aveva preso per buono il presunto alibi fornito dalla figlia del barista, che ricordava Zorzi a chiacchierare con un rappresentante di commercio (“Certo Galvani Massimo”) e un ragazzo barbuto (“certo Claudio Antolini”).
Nessuno di loro era stato interrogato, nessuna foto era stata mostrata, eppure “La signorina Daniela era certissima, ed è apparsa sincera ed attendibile nonché disinteressata, della presenza dello Zorzi sino ad oltre le ore 10 del mattino del 28 maggio”. La notizia del fermo di un certo Roberto Z. era finita sul Corriere della Sera del 30 maggio a firma di un inviato specialissimo come Giorgio Zicari, che di lì a qualche giorno sarebbe stato travolto dallo scandalo della sua collaborazione con i Servizi – un Renato Farina ante litteram – nell’affaire del Mar di Fumagalli. Di Zorzi, invece, non si era saputo più nulla. Certo, l’etichetta di estremista negli anni gli aveva procurato qualche noia, facendolo controllare o perquisire dopo l’omicidio di Vittorio Occorsio (1976), la strage di Bologna (1980) e quella al Rapido 904 del Natale 1984. Ma aveva potuto candidarsi (non eletto) alle comunali di Verona dell’80 nelle liste del Msi, vivere la sua svolta mistica, laurearsi in Teologia a Trento, portare la famiglia negli Usa e aprire quell’allevamento intitolato al fascio e dedicato alla “Regina Pacis”, la madonna. Lontano dalle accuse dell’ex camerata Zamboni: “Stefano Romanelli mi disse che lo Zorzi aveva fatto il botto, con ciò intendendo il nostro Zorzi, cioè il Roberto, si accesero i suoi occhi quando me lo disse”.
Una pagina di appunti del giudie Occorsio
Le caserme
Indagini insabbiate, sottufficiali che girano la testa dall’altra parte. Il cliché è noto. I nuovi accertamenti sull’alibi di Zorzi rivelano plasticamente il depistaggio. La “signorina Daniela” citata nel rapporto Delfino viene rintracciata a distanza di 41 anni. Si scopre che all’epoca era una ragazzetta di 16 anni che dava una mano al padre. Non solo non ricorda il biondino coi baffi alla maniera del Führer, ma nemmeno i carabinieri. Ha solo un vago flash, talmente etereo da collocarlo all’epoca della bomba alla stazione di Bologna: due signori in borghese che entrano, fanno un paio di domande al padre e quest’ultimo che gliele rivolge. Non ha idea di chi siano Galvani e Antolini. Tocca al Ros rintracciarli. Il primo abitava vicino a Zorzi, sa chi è, faceva il marmista e ne conosceva il padre, ma la mattina della strage non lo ha mai incrociato. Claudio Antolini, invece, è imparentato con il marcantonio, avendo sposato Maria che è cugina di Paola Crescini in Zorzi. Lo ricorda, quel fermo, non certo quell’incontro al bar. Anzi, la signora Maria aggiunge che in quella fine di maggio del 1974 nel cortile di casa, seminascosta da una siepe, sostava una Dyane celestina. Le ricerche riescono a risalire al proprietario: Elio Massagrande, il vecchio leader di Ordine Nuovo a Verona, che per sfuggire agli arresti era scappato in Grecia e aveva lasciato le chiavi della “due cavalli” ai suoi adepti. Molte tessere cominciano a incastrarsi. Zamboni, che morirà nell’ottobre 2015 lasciando le sue rivelazioni a metà, riesce ancora ad aggiungere una cosa: correva, tra i neri di On, l’idea di commettere stragi indiscriminate, di fare i morti per scuotere il Paese ed invocare il governo forte. Il regime. Qualche neonazista si era tirato indietro, altri ci stavano
Poiché poche o pochissime persone possono fare tutto, ma se io parcellizzo, cioè specializzo al massimo ognuno partecipa per un piccolo contributo e, se venisse preso e parlasse, potrebbe al massimo raccontare il suo compito
Naturalmente, dice, in quel giro “se si entrava, non si usciva”. Già, ma dove era nata quell’idea? Bisogna seguire Alfa, e il filo dei suoi verbali. Dei suoi diari di viaggio postumi, accanto a Silvio Ferrari. Quelle foto scattate a Delfino non erano state fatte a Brescia, spiega. Ma a Verona. Insieme, il ragazzo destinato a morire e il supertestimone erano andati più volte. In una caserma dei carabinieri affacciata su un fiume, con una grande sala nello scantinato dove si tenevano delle riunioni. I Ros riportano Alfa in quei luoghi, sperando in un effetto rabdomante. Il “bastone” ne indica tre. La caserma dei carabinieri di Parona Valpolicella, sul Lungadige alla periferia nord di Verona, con una sala nello scantinato e un accesso posteriore proprio come scritto a verbale. Ma poi, passando davanti a un anonimo palazzo di via Montanari, Alfa si blocca: “Qui ci siamo stati con Silvio”. Ed è un’indicazione pazzesca perché in quell’edificio di proprietà dell’Inps, all’ultimo piano, il Sid aveva insediato per trent’anni la segretissima sede del Centro di controspionaggio. Infine il sopralluogo si dirige verso via Roma. “Ecco, in quel palazzo siamo entrati. Ma non dal portone: da quell’accesso con la sbarra, che porta in cortile”. È l’entrata secondaria, riservata agli inquilini del condominio adiacente, di Palazzo Carli, la sede del Comando Ftase. La Nato.
Gli attentati
“Lì, prima di entrare, Silvio era atteso un ragazzo che già avevamo visto nella caserma del seminterrato”. Sull’album fotografico, il dito si ferma al volto numero 6. “Questo qui, una persona tremenda e molto determinata, l’avevo fuori già all’esterno della pizzeria Ariston a incontrarsi con gli altri veronesi e con Silvio, sarà stata una settimana prima della sua morte”. È Marco Toffaloni. E quella riunione fu parecchio animata, si parlava di esplosivo, secondo il supertestimone, roba “che non era più possibile prendere da una certa caserma di Verona e che lo deve prelevare dalla caserma Papa di Via Volturno a Brescia”. Di un attentato, da commettere la sera del 18 maggio in una delle prime discoteche gay di Brescia, il Blue Note. Ed in effetti, nella scia di attentati che precedettero piazza della Loggia, quello fu un episodio anomalo: due telefonate anonime, entrambe effettuate da Ermanno Buzzi alla Polstrada e alla Guardia di Finanza, innescarono un rapido e vistoso controllo che tenne alla larga i bombaroli. Buzzi frequentava il Blue Note e non voleva guai ai suoi amici e ai poliziotti che lo frequentavano, di cui era confidente. Secondo Alfa, il piano proveniva dalla caserma veronese: “Alle riunioni di Parona fu detto che in realtà l’obiettivo non era il locale, ma il proprietario dello stesso”, e cioè Marco Bruschi, “perché un funzionario della Questura andava”, e cioè Vincenzo Via, il capo dell’Ufficio Politico. Un progetto incredibile. Forse inverosimile. Come la promessa che era stata fatta a Ferrari: dopo il botto sarebbe stato trasferito a Milano, dove aveva agganci con i neri della Fenice, gli sarebbe stato trovato un appartamento vicino al Tribunale dove organizzare una nuova azione e avrebbe lavorato sotto copertura.
Ne ha dato indiretta conferma il generale Domenico Sevi, all’epoca in servizio al controspionaggio e convocato un giorno nella caserma dei carabinieri di via Moscova dall’allora capitano Umberto Bonaventura: stavano preparando, gli disse, l’arrivo del neofascista bresciano a Milano. Solo che, all’ultimo minuto e timoroso di una trappola, Silvio Ferrari avrebbe fatto di tutto per tirarsi indietro e sparire dalla circolazione, magari con un nuovo lavoro a Verona che avrebbe sopperito l’impiego nella concessionaria auto dei genitori. E portandosi dietro le foto più compromettenti, quelle delle riunioni pre-stragiste, come garanzia. Vero? Falso? Nel frattempo, il supertestimone aggiunge nuove pennellate al suo affresco. Ripesca dalla memoria un’altra riunione con i veronesi, nella settimana tra il 21 e il 28. Con Toffaloni, assicura
Vi era il Marcantonio, Roberto Zorzi, che si sarebbe occupato della vendetta per la morte del Silvio
E poi svela i nomi mancanti alla riunione preparatoria, quella col discorso concitato sull’esplosivo che non si trovava. Uno è Paolo Siliotti, un neofascista scomparso nel 1980 in un incidente di moto, ricco di famiglia e frequentatore dei giri giusti, compresi quelli del calcio: Pierluigi Busatta e Sergio Vriz, mediano e fantasista del Verona degli anni Settanta, erano spesso nella sua villa di famiglia. Ora – in uno dei passaggi più paradossali dell’intera indagine – si ritrovano interrogati in un procedimento per strage, alla ricerca (vana) di ricordi e collegamenti con un ambiente, quello ordinovista, che all’epoca avevano solo e inconsapevolmente sfiorato. L’altra partecipante alle riunioni sui locali da far saltare sarebbe stata, a dire di Alfa, la ragazza più bella e corteggiata di Verona, Anna Rita Terrabuio, che ebbe un breve momento di celebrità proprio in quegli anni, quando fece perdere la testa a Fabio Testi che per lei lasciò nientemeno che Ursula Andress. A 42 anni dalle copertine dei rotocalchi, è in grado di riconoscere in foto “Tomaten”. La spruzzata di gossip non dà però sbocchi perché tutti i compagni e le amiche di Terrabuio, compreso Testi interrogato tra un’Isola dei Famosi e un’ospitata, negano che da liceale avesse un qualsiasi interesse politico, men che meno eversivo. La diretta interessata, a verbale, non può che ribadirlo.
I due calciatori del Verona per l’album Panini
Gli ufficiali
La digressione rosa, innescata dalla superteste, porta fino al controllo di un’agenda del defunto Spiazzi su cui, alla data del 4 agosto 1980 (due giorni dopo la bomba di Bologna) il cognome Terrabuio era annotato accanto a quello di Zorzi. Non si sa, però, a che titolo. Altro, però, è per gli investigatori il cuore del problema. Cioè credere alla sconvolgente ipotesi che ufficiali che avevano giurato sulla Costituzione potessero farsi complici e strateghi di un piano assassino, oltre che golpista. Anche perché i nomi che riempiono i faldoni dell’indagine, quelli dei presunti partecipanti a quelle riunioni di Parona e poi di Palazzo Carli, sono pesantissimi. C’è il già citato Delfino, ufficiale dalla carriera fulminante ma eternamente macchiata da due ombre, entrambe bresciane: piazza della Loggia e il sequestro dell’industriale Giuseppe Soffiantini, che gli procurò una condanna per truffa aggravata. C’è Angelo Pignatelli, all’epoca titolare del Centro Cs Verona e ufficiale che godeva della massima fiducia del generale Gianadelio Maletti, l’allora capo del controspionaggio che finirà condannato per i depistaggi su piazza Fontana e morirà latitante a Johannesburg. Una ricerca documentale su Pignatelli (grossa parte delle 280mila pagine del colossale incarto proviene da archivi di Aise, Aisi, comandi dell’Arma e Stato Maggiore di Esercito e Aeronautica) ha fatto riesumare un documento sugoso: il 28 maggio 1974, il giorno della strage, Pignatelli – che Silvio Ferrari chiamava semplicemente “Angelo”, secondo i racconti di Alfa – era in Germania Ovest in ragione del suo fluente tedesco, a organizzare, insieme ai colleghi del Bka, la missione del Sid in Germania Ovest per scortare, con sei spie, la Nazionale di Valcareggi ai Mondiali di calcio, due anni dopo la strage di Settembre nero alle Olimpiadi di Monaco. Torneranno sani e salvi ma coperti di “azzurro tenebra”, Facchetti e compagni.
Il dispositvo di protezione del Sid (Servizio informazioni difesa) per la Nazionale di calcio ai Mondiali del 1974 Infine, tra le foto associate a Parona e Palazzo Carli, c’è quella di un giovane Mario Mori, altro ufficiale “dannato” della stagione delle stragi. Su di lui, il colonnello Giraudo indagava già per conto della procura di Palermo, all’interno del processo sulla trattativa. E i documenti d’archivio legano Mori a Brescia, ma alla lontana, in due diversi modi. L’ufficiale, all’alba di una carriera che lo avrebbe portato al vertice del Ros e del Sisde, era giovane tenente a Villafranca Veronese e bazzicava l’ambiente Ftase. Inoltre, era presente a Pian del Rascino subito dopo la morte di Giancarlo Esposti, e qui va aperto un altro cassetto di questa infinita vicenda: Esposti, neonazista sanbabilino, trafficante d’armi e fonte del controspionaggio milanese, era in tenda insieme a tre camerati sulle alture del reatino la notte del 30 maggio 1974, a 48 ore dall’eccidio bresciano. Ufficialmente latitante, lucidava i mitra in attesa di un colpo di Stato. Arrivarono i carabinieri, invece, e cadde nel conflitto a fuoco, e da allora i sospetti che lo legano a piazza della Loggia non si sono mai diradati del tutto. Mori, si diceva, a metà del ’74 era ufficiale del Sid al Raggruppamento Centri di Roma, nella branca che si occupava di reclutare i defezionisti dalla Bulgaria comunista, e assorbirne le informazioni. Esposti, in tasca, aveva nomi e indirizzi di un paio di questi. Roba da agenti sotto copertura, da far sparire in fretta. Così come andavano coperte e ingoiate, secondo i racconti di Alfa, le possibili allusioni alle riunioni di Parona e alle foto, oggetto di avvertimenti e minacce fin dai giorni dopo la strage. In uniforme, e particolarmente energici, sarebbero stati quelli di Delfino. Morbidi, e in borghese, quelli di Mori.
Palazzo Carli
Oggi è di nuovo appannaggio dell’Esercito italiano ma quell’insediamento Nato, in piena guerra fredda, era il più grosso centro di potere militare sul nostro territorio, insieme a quello di Napoli. Gli ufficiali che ne popolavano gli uffici erano per la maggior parte italiani, ma non solo. Ogni addetto vivente, e sono decine, è stato scovato dagli investigatori ed ha dovuto rispondere a domande sull’ipotesi di un centro occulto di stragismo. Nessuno, ovviamente, ha confermato l’indicibile passaggio di alcuni ragazzini con velleità al tritolo. Ragazzi, però, con ricordi nitidi, se è vero che Alfa ha saputo riconoscere i portici interni e la scala in fondo a sinistra nel portico, che portava direttamente agli appartamenti privati del comandante. O indicare la presenza di un ufficiale con il basco amaranto, quello dell’Aeronautica, e all’epoca esisteva davvero l’ufficiale di collegamento Oscar Santoli. O ancora parlare di “Eva”, la spia polacca Anka Dirani, e indicarla come amante dell’allora colonnello Lucio Innecco, ufficiale chiacchieratissimo – il Sid, tramite Pignatelli, lo pedinerà per mesi sospettandolo di simpatie comuniste e di intese col nemico, senza però trovare riscontri – e amico delle famiglie Siliotti e Terrabuio. L’ordinovista Claudio Lodi lo ricorda frequentatore delle stesse palestre di arti marziali dove si addestravano i camerati. Perfino l’ex calciatore Vriz ricorderà Palazzo Carli tra i luoghi frequentati dal suo amico Paolo Siliotti. Tracce, parziali ma solide, della frequentazione di Delfino al comando risalgono a una sua partecipazione dietro invito al ricevimento dopo la liberazione del generale James Lee Dozier, sequestrato dalle Br a fine 1981 e liberato due mesi dopo.
Silvio parcheggiava all’interno e veniva ricevuto dal Cap. Delfino in uniforme nera – riferisce ancora Alfa – e c’erano altri militari in uniforme carta da zucchero, un azzurro verso il blu. lo non li seguivo mai, rimanevo vicino alla motoretta e poi Delfino lo riaccompagnava, talvolta proprio fino alla motoretta, talvolta fermandosi al centro del cortile
E c’è un riscontro interno, l’ex capitano Massimiliano Rossin, che ha confermato agli investigatori i plurimi passaggi non registrati di Delfino e Pignatelli nel quartier generale. È sufficiente? Possibile? Credibile? Vero? L’ultima fase dell’indagine, non a caso etichettata “Deep State”, con quel sistematico carotaggio dei fondali della Repubblica alla ricerca di inconfessabili collusioni, ha trovato qualche porta chiusa. Carabinieri che indagano su carabinieri, e sulle altre Armi, lo Stato che interroga sé stesso e mette a processo propri pezzi, bollandoli come deviati, magistrati che aprono armadi riservati, in un cortocircuito di ipotesi, sospetti e bivi tra verità indicibili (se tutto l’impianto venisse dimostrato) e schizzi di fango indesiderati anche per l’alleato. Bertram Gorwitz, nome di battaglia “Igor”, era all’epoca l’ufficiale più in vista, la mente grigia del comando Ftase. Era anche il punto di riferimento del colonnello Innecco, ed è ovvio che qualsiasi piano elaborato a Palazzo Carli dovesse passare da lui. La scaletta in fondo al portico indicata da Alfa conduceva al suo cospetto. È stato riconosciuto in foto. Il generale non può rispondere, però: riposa dal 1997 ad Arlington.
Le divise coinvolte
Gli assenti
Non hanno risposto finora, né Marco Toffaloni né Roberto Zorzi. Del secondo, tra le carte, si trova traccia di una fugace telefonata via Whatsapp al colonnello Giraudo, con toni di scherno e vaghe promesse mai onorate di rientro in Italia per mettersi a disposizione dei magistrati. Sul suo conto gli investigatori sono riusciti a collezionare altre significative testimonianze, quelle di Ferdinando Trappa, uomo che trafficava in quadri rubati insieme ad Ermanno Buzzi. E che giura di aver assistito ad un incontro tra i due, a un distributore notturno di benzina, poco prima della strage. C’è, poi, un ulteriore tassello alle descrizioni fatte da Alfa, un recente vivido dettaglio sulla riunione dopo la morte di Silvio Ferrari: “Quello che non ha fatto lui dobbiamo farlo noi. Questa frase fu pronunziata dal Roberto Zorzi e me lo ricordo come il personaggio carismatico al tavolo”. Di “Tomaten”, gli inquirenti hanno potuto stabilire la militanza strettamente legata a quella del “pirata” fin dall’inizio del 1974, a distribuire i giornalini di Anno Zero o a fare propaganda antidivorzista per i Guerriglieri di Cristo Re. La foto e i rilievi antropometrici sono riscontri solidi. La sua carriera da attentatore un punto a favore di chi lo accusa. E poi ci sono le recentissime aggiunge del supertestimone, verbalizzate dal pm Caty Bressanelli e dal procuratore aggiunto Silvio Bonfigli. “Alla fine Silvio evidentemente si lascia convincere anche perché pensava magari di cambiare vita, di andare a Milano. La sera prima della morte ricordo Nando (Ferrari, ndr), Arturo Gussago e Silvio e dall’altra parte Siliotti Zorzi e Toffaloni”.
Già, Gussago, che negli anni Settanta patì l’infamia del carcere preventivo e delle accuse poi sbriciolate a processo insieme ad Andrea Arcai, figlio del magistrato Giovanni, e a Mauro Ferrari, il fratello minore di Silvio, il proprietario della Vespa saltata in aria, accusato di volersi vendicare col tritolo. Anzi, col Vitezit, lo stesso esplosivo usato con ogni probabilità in piazza Fontana: un candelotto venne trovato al ragazzo in cantina, probabilmente messo apposta da chi lo voleva incastrare con una perquisizione ad arte. Gussago, si diceva: “Era una brava persona, non mi ha mai detto che voleva ammazzare Silvio o fare una strage, lui ha sempre voluto rimanere nell’ombra ma c’era”, giura Alfa. E adesso che è morto così tragicamente, appena chiuse le indagini su Zorzi e Toffaloni, bisogna davvero parlarne al passato, e aggiungerlo all’elenco di chi non potrà difendersi. Proprio per questo sarà bene condividere la prudenza di Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria, che con i legali di parte civile sta leggendo in questi giorni le carte: “Siamo in una fase molto delicata, soprattutto per i testimoni che hanno parlato e dovranno parlare. Stiamo approfondendo con gli avvocati, sappiamo che l’indagine si è svolta in continuità con l’ultimo processo. Speriamo si prosegua in quella direzione”. Quella dei colpevoli accertati. L’unico modo per far pace con quel passato. Qualunque sia la verità.
Piazza della Loggia, Brescia 2021